categoria: Vicolo corto
Se la montagna rinasce grazie alla tecnologia

Post di Rodolfo Pinto, Fondatore e CEO di SuperUrbanity, la urbantech company che affronta le sfide globali su scala urbana attraverso la tecnologia e l’innovazione –
Le montagne, da tempo, sono trattate come terre marginali. Spazi naturali e remoti spesso incontaminati e destinati al turismo stagionale, o al racconto di una vita lenta e distante dai ritmi frenetici della città. Spazio urbano e spazio rurale, in una dicotomia secolare, ma che mai come prima d’ora sta vivendo un ribaltamento ed un nuovo rapporto biunivoco e per certi versi simbiotico.
La montagna da un lato è la sentinella del cambiamento climatico, vittima dello scioglimento dei ghiacciai (oltre il 40% del volume perso negli ultimi vent’anni)[1], della perdita di biodiversità e del conseguente effetto su leve economiche che ne hanno segnato il benessere come gli sport invernali. Dall’altro lato le città sono diventate oggi luoghi spesso inospitali che aumentano la percezione della crisi climatica che stiamo vivendo: soffrono di isole di calore, alluvioni, eventi meteorologici estremi.
I modelli urbani europei e più tipicamente italiani sono stati progettati in base a condizioni climatiche che non esistono più. La qualità della vita peggiora, i tempi e gli spazi urbani si comprimono e gli effetti sulla salute sono evidenti. Alla luce di questo, le aree montane stanno riconquistando centralità, e lo stanno facendo proprio grazie alla forza che per decenni sembrava una debolezza: la loro distanza, il loro paesaggio, la loro resilienza ma anche il loro essere custodi di alcuni beni rari e ricercatissimi dalla civiltà urbana, ovvero foreste, aria pulita, comfort climatico e minore densità abitativa.
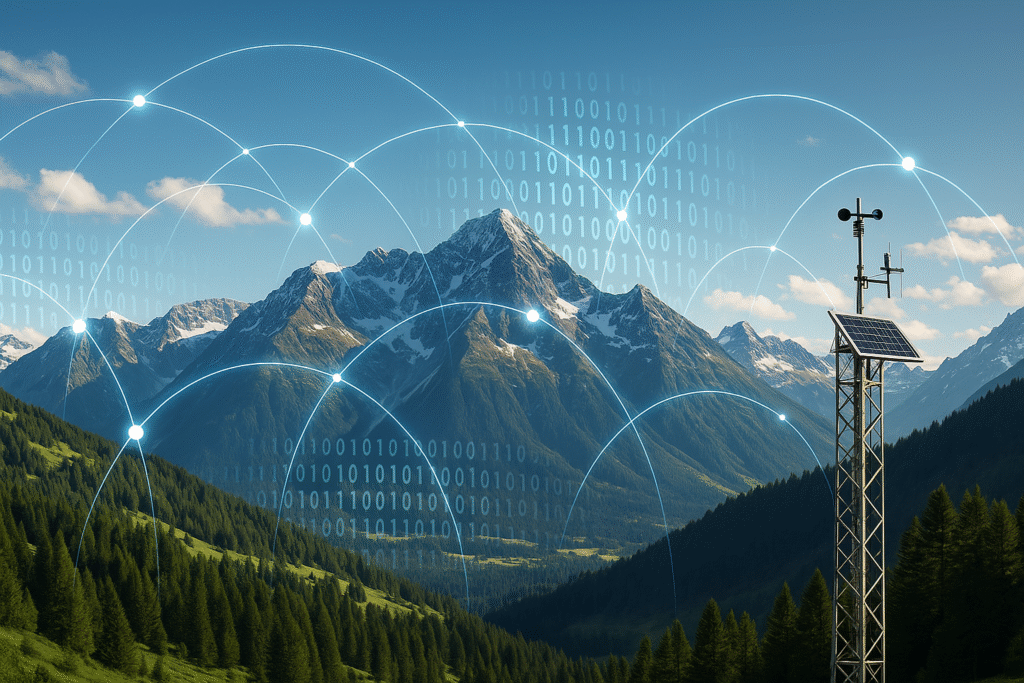
Tecnologia e natura si incontrano: piattaforme digitali e infrastrutture smart rendono le montagne spazi cruciali di sperimentazione
Dopo anni di spopolamento, secondo il rapporto Montagne Italia 2025 di UNCEM, in alcune aree montane si registra un aumento netto di residenti permanenti, una domanda crescente di seconde case e un’intensificazione dell’offerta turistica legata a esperienze sostenibili e rigenerative con oltre 100.000 abitanti guadagnati in 5 anni.
Ma questa inversione di rotta non è solo demografica. È culturale, economica, infrastrutturale. E ha bisogno di visione e strumenti. Serve un nuovo paradigma per le aree montane, che smetta di considerarle aree “interne” solo in senso geografico, e inizi a riconoscerle come aree centrali di sperimentazione sostenibile, sia per l’Italia che per l’Europa.
Un nuovo baricentro strategico
Il documento “Strategia per le montagne e le aree interne” elaborato da UNCEM (marzo 2025), in sinergia con il percorso della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), individua proprio in questo cambio di prospettiva la chiave per il futuro: superare l’approccio emergenziale e settoriale, e valorizzare la montagna come ecosistema connesso, dinamico, interdipendente. Si tratta di un territorio che ospita 3.900 comuni italiani, che si sviluppa su quasi la metà della superficie nazionale ed è il primo presidio ambientale contro il cambiamento climatico.
Non è solo questione di paesaggio. Le montagne custodiscono risorse idriche, biodiversità, foreste strategiche per l’assorbimento della CO₂, produzioni agroalimentari di alta qualità. Sono una delle infrastrutture naturali più importanti del continente. Ma sono anche spazi sociali: luoghi di coesione, artigianato, saperi, economie di prossimità.
Tuttavia, per essere davvero un motore di sviluppo, questo patrimonio deve essere moderno, connesso, abitabile. E qui entra in gioco la tecnologia.
Il digitale come infrastruttura abilitante
L’innovazione digitale, ma in generale l’approccio all’innovazione tipico delle città deve trasferirsi per osmosi alle aree interne perché queste abbiano gli strumenti adatti al tempo che viviamo. Per risignificare questi territori e progettare politiche efficaci, serve una base solida di conoscenza. Tecnologie di raccolta dati (sensoristica, satelliti, open data territoriali) e sistemi avanzati di analisi possono fornire una lettura dinamica e predittiva del territorio: monitoraggio dei dissesti, mappatura dei cambiamenti climatici, studio delle dinamiche demografiche ed economiche locali, ma anche individuazione di quei beni dismessi che possono essere rivitalizzati, così da diventare attivatori di comunità e nuove economie.
Ma i dati non bastano. Occorre cambiare il modo in cui si utilizzano per governare il territorio. Il modello tradizionale – verticale, frammentato, emergenziale – non è più adeguato. Al suo posto, serve una governance collaborativa, digitale e multilivello, capace di connettere enti locali, imprese, associazioni e cittadini in una logica di coprogettazione.
Attraverso piattaforme digitali di partecipazione, è possibile coinvolgere le comunità nella gestione di risorse dismesse – come ex colonie industriali o vecchie caserme, malghe, stazioni forestali – o nella tutela di beni ambientali come pascoli, boschi e sentieri. Questi strumenti non sono solo spazi di ascolto, ma veri e propri hub di rigenerazione civica ed economica: luoghi dove far emergere idee, attivare iniziative, connettere risorse pubbliche e private.
Progetti pratici che vanno in questa direzione si stanno sviluppando in diverse località del nostro Paese ed anche la società che guido, Superurbanity, sta contribuendo grazie alla collaborazione con l’Università di Bergamo per una iniziativa pilota che porterà un hub digitale e condiviso al servizio delle terre alte prealpine nell’area del bergamasco. L’obiettivo, in ottica scalabile, sarà poi quello di esportare i benefici anche in altre aree interne dell’arco alpino e appenninico.
Un’agenda montana per l’Italia (e l’Europa)
Questa trasformazione non riguarda solo l’Italia. Le Alpi, ad esempio, sono condivise da sette Stati europei. Costituiscono un’area geopolitica che può diventare una piattaforma di cooperazione transnazionale su temi cruciali: energia, risorse naturali, mobilità sostenibile, gestione forestale, e adattamento climatico. Una grande area in cui l’identità legata ai valori naturali e culturali della montagna supera le singole identità nazionali e genera quindi spazi di collaborazione, condivisione di best practice, creazione di modelli virtuosi.
La montagna quindi non è più luogo isolato o fragile, ma può diventare piattaforma di sperimentazione del futuro. Qui possono nascere progetti pilota di edilizia sostenibile, prototipi di governance digitale, strategie di gestione dei rifiuti decentralizzate, percorsi formativi diffusi. Qui può concretizzarsi un modello di sviluppo in cui il benessere non è dato solo dalla crescita economica, ma dalla qualità della vita, dalla coesione sociale e dalla rigenerazione dei territori.
È un’occasione unica: ricucire i rapporti tra città e montagna, tra centro e margine, tra tecnologia e natura ed è essenziale portare le aree montane e in generale le aree interne nel futuro, dotandole di tecnologia, dati, e modelli predittivi per dare alle amministrazioni locali quegli strumenti che servono per dare una prospettiva nuova e diversa alle proprie comunità, ma anche per divenire un’area di decompressione climatica e socio economica per il metabolismo delle città, soggetto a pressioni crescenti e sempre più difficili da sostenere.
[1] © FT • Sources: Global Land Ice Measurements from Space glacier database; University of Edinburgh
