categoria: Econopoly
Regime forfettario, è davvero un privilegio? Tutte le risposte al Fmi
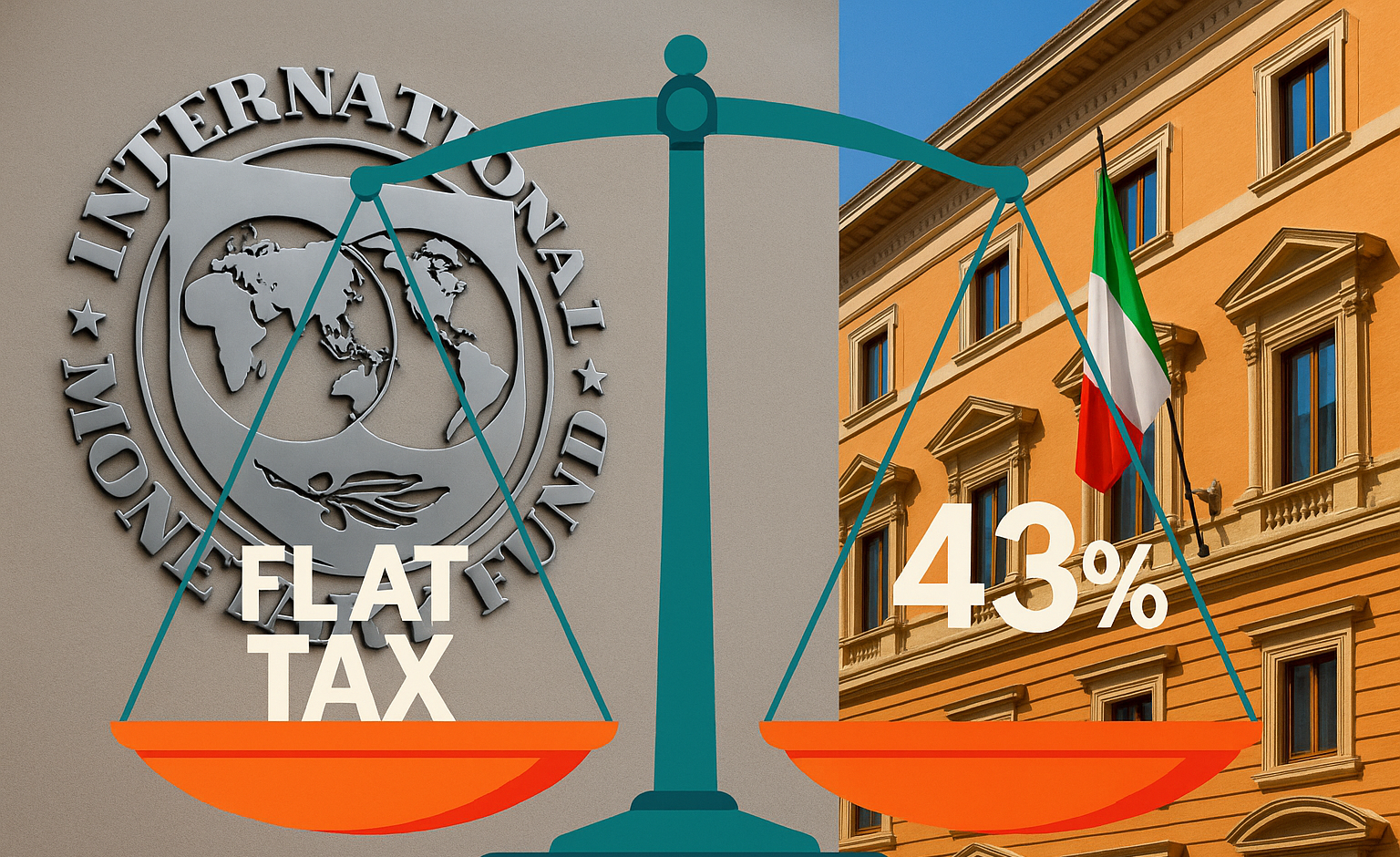
Post di Elena Battistini, commercialista Partner di Fiscozen –
Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha recentemente espresso forti critiche sulla “flat tax”, la tassazione ad aliquota fissa del 15% (5% per le nuove attività) sui redditi dei liberi professionisti che aderiscono al regime forfettario. Non solo, il FMI ne ha suggerito addirittura l’abolizione, ritenendo che questa misura sia poco equa, crei squilibri nel sistema fiscale e favorisca l’evasione, oltre a sottrarre gettito allo Stato.
Nello specifico, viene contestato al regime forfettario di:
– generare un carico fiscale inferiore rispetto all’Irpef dei lavoratori dipendenti, i cui redditi sono soggetti a scaglioni progressivi;
– favorire l’evasione, sostenendo che il regime forfettario potrebbe incentivare la frammentazione delle attività per rimanere sotto le soglie di reddito che danno diritto alla flat tax (riducendo così la base imponibile e il gettito fiscale);
– essere poco sostenibile nel lungo periodo se non accompagnato da altre misure di riforma fiscale;
– creare distorsioni nel sistema fiscale, riducendo l’efficacia della progressività e danneggiando la concorrenza tra imprese.
Il governo italiano, al momento, non sembra intenzionato ad abolire la flat tax, nonostante le raccomandazioni dell’istituzione con sede a Washington D.C., nata nel dicembre 1945 per promuovere la stabilità finanziaria e la cooperazione monetaria a livello globale.
A mio parere, in effetti, la flat tax aiuta a contrastare l’evasione, apporta benefici in termini di semplificazione e riduzione della burocrazia e favorisce la crescita economica oltre alla regolarizzazione fiscale.
È corretto dire che il regime forfettario, con il suo 15%, è un’eccezione ingiusta in un sistema dove gli altri pagano aliquote Irpef fino al 43%?
Questa è una narrazione molto diffusa ma imprecisa, che non tiene conto di come funziona realmente il nostro sistema fiscale e del concetto di aliquota effettiva. Innanzitutto il regime forfettario è “blindato”, cioè la sua aliquota del 15% (o 5% in fase di avviamento) si applica solo ed esclusivamente ai redditi prodotti all’interno di quel regime. Non può essere quindi usato per “dirottare” altri tipi di reddito e per tassarli meno.
Quanto all’idea che i dipendenti paghino il 43%, è un falso mito. Il nostro è un sistema a scaglioni marginali. Significa che le aliquote più alte si applicano solo sulla porzione di reddito che supera una certa soglia, non su tutto il reddito.
Per esempio, su un reddito lordo di 85.000, i primi 28.000 € sono tassati al 23% (quindi 6.440 €), la parte tra 28.000 e 50.000 euro è tassata al 35% (altri 7.700 €) e solo la porzione che supera i 50.000 € viene tassata al 43% (15.050 €). L’imposta totale è quindi di 29.190 €. Questo porta l’aliquota effettiva (cioè l’imposta reale pagata sul totale) al 34,3%, un valore lontano di oltre 10 punti dal 43%.
A parità di reddito, quindi, un forfettario versa comunque meno di un dipendente?
Anche qui, i dati e un confronto diretto ci portano a concludere che in media, non è così. Anzi, spesso è il forfettario che versa più del dipendente.
Prima di tutto, va considerato che il lavoratore dipendente ha un vantaggio fondamentale che il forfettario non ha. Ovvero, la possibilità di dedurre e detrarre una vasta gamma di spese, riducendo così la parte tassabile e quindi l’imposta finale.
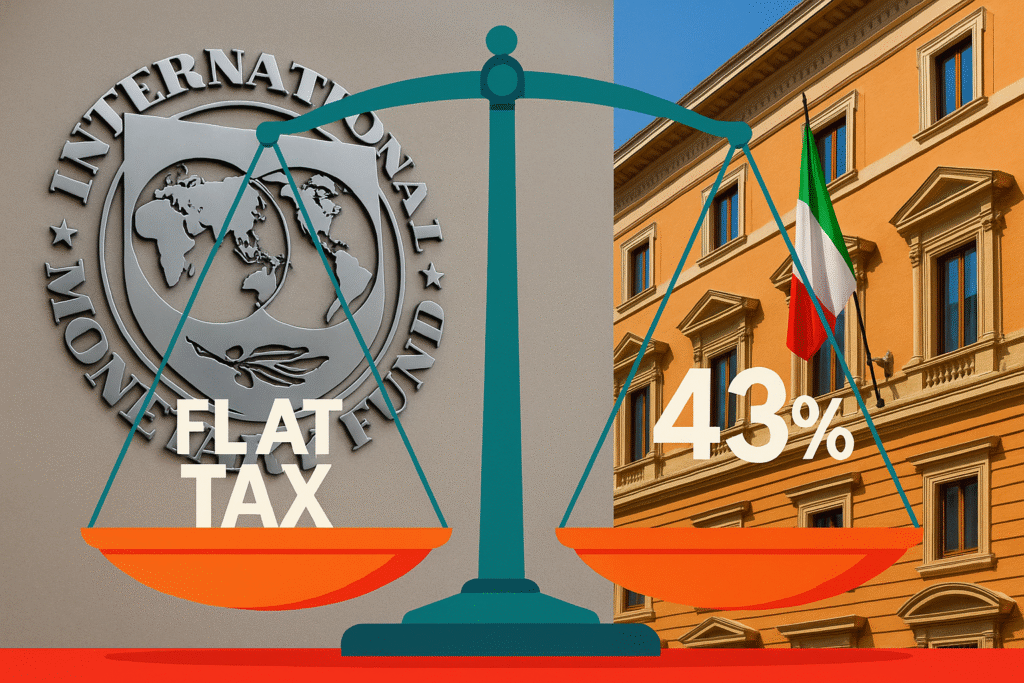
I dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2023 parlano chiaro: 14,7 milioni di italiani hanno ricevuto un rimborso Irpef (questo non significa che hanno pagato meno imposte in assoluto, ma che il loro datore di lavoro aveva trattenuto più del dovuto durante l’anno, e lo Stato ha restituito loro la differenza dopo aver conteggiato le spese detraibili), 14,9 milioni di contribuenti hanno scaricato oneri deducibili, quindi non tassabili, e oltre 7 milioni di persone hanno usufruito di detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Il forfettario, invece, non può scaricare spese: né quelle mediche, né gli interessi del mutuo, né i costi per i figli a carico, né le spese professionali reali. Ha solo una deduzione a forfait del 22%.
Una narrazione da ribaltare
Facendo infatti un confronto diretto tra un dipendente e un consulente in regime forfettario, basandosi sul reddito medio Irpef di 25.770 €, emergono numeri in grado di ribaltare la narrazione. A parità di reddito lordo/fatturato, il forfettario applica la sua deduzione fissa del 22%, portando il reddito da tassare a 20.100 euro. Su questa cifra, la sua imposta al 15% è pari a 3.015 euro. A questa, però, deve aggiungere i contributi per la pensione (ipotizziamo gestione separata al 26%), che sono interamente a suo carico e ammontano a 5.226 €. Il suo totale versato allo Stato è quindi di 8.241 euro, lasciandogli in tasca un netto di 17.529 €.
Il dipendente, con lo stesso reddito lordo di 25.770 euro, paga 5.927 di Irpef. I suoi contributi pensionistici sono in gran parte versati dal datore di lavoro e non intaccano direttamente questa cifra. Il suo netto in tasca è quindi di 19.843 €. E questo ipotizzando zero detrazioni per il dipendente.
In altre parole, a parità di lordo, il forfettario versa allo Stato (tra imposte e contributi) oltre 2.300 € in più rispetto al dipendente.
Il regime forfettario favorisce l’evasione?
I dati ufficiali suggeriscono di no. Da un’analisi del Governo sugli effetti dell’aumento della soglia a 65mila e poi a 85mila euro, emerge chiaramente che i ricavi dichiarati dai forfettari sono cresciuti in media del 5,9%, con punte del 14,5% tra i professionisti.
Il cosiddetto “effetto soglia”, cioè la tendenza a fermarsi appena sotto il limite di fatturato, non equivale necessariamente ad evasione: spesso è una scelta legittima, come interrompere l’attività, andare in ferie o posticipare fatture all’anno successivo. Alzare la soglia ha reso possibile continuare a lavorare senza nascondere ricavi, facendo emergere attività che prima restavano ferme o sommerse.
Quindi, anziché essere uno strumento che favorisce l’evasione, i dati suggeriscono che un regime forfettario ben congegnato e con una soglia adeguata agisce come un potente incentivo alla trasparenza e alla crescita economica.
È possibile utilizzare il regime forfettario per tassare altri redditi?
No. Non siamo di fronte ad un’agevolazione ingiustificata e poco equa, ma ad un regime fiscale con limiti ben precisi, concepiti proprio per prevenire abusi. Per esempio, una persona non può accedere o rimanere nel regime forfettario se nell’anno precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiori a 35.000 euro. È escluso dal regime chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari. Non può avvalersene chi controlla, direttamente o indirettamente, una società a responsabilità limitata (Srl) che esercita un’attività simile a quella della sua Partita Iva. Viene escluso dal regime chi ha percepito più di metà del reddito annuale da un ex datore di lavoro. Inoltre, le spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non possono superare i 20.000 euro lordi annui.
Infine, è fondamentale ricordare che il forfettario è un regime individuale: non si può aprire una Partita Iva forfettaria in società con qualcuno, è un percorso personale e ogni individuo può esserne titolare per una sola attività.
Gli altri redditi per i forfettari vengono infatti tassati ben sopra il 15%. Ad esempio: gli affitti con cedolare secca al 21%, i redditi da investimenti finanziari al 26%, gli utili di società di capitali al 24% (IRES).
Cosa succederebbe se abolissimo il regime forfettario come suggerito dal FMI?
Oggi quasi la metà delle Partite Iva italiane, 1,79 milioni su 4,1, lavora in forfettario. Per molti è l’unica via per mettersi in proprio. Se venisse abolito, oltre un milione e mezzo di lavoratori si troverebbe a scegliere tra passare al regime ordinario, con costi molto più alti, o chiudere l’attività. È probabile che in tanti sceglierebbero la seconda opzione, con un effetto immediato sull’occupazione, sull’offerta di servizi e sul tessuto economico locale.
Lo Stato rischierebbe di perdere sia entrate fiscali sia contributi previdenziali, dovendo in più sostenere i costi sociali di chi resta senza lavoro. In altre parole rinuncerebbe a un’entrata certa per una spesa altrettanto certa.
Le conseguenze dell’abolizione del regime forfettario
Il regime forfettario resta oggi lo strumento più importante per sostenere chi lavora in Partita Iva e permettere a migliaia di persone di intraprendere un percorso professionale indipendente. Abolirlo, come suggerito dal FMI, significherebbe colpire non solo i professionisti che lo utilizzano, ma l’intero tessuto economico italiano.
Il forfettario non è una scorciatoia fiscale, è una scelta di politica economica che ha dato a tanti la possibilità di emergere, mettersi in regola e contribuire alle casse dello Stato. Togliere questa opportunità non aumenterebbe il gettito, ma rischierebbe di ridurre il numero di contribuenti e aumentare i costi sociali. Al contrario, andrebbe rafforzato e reso più stabile, perché è una leva di crescita e trasparenza.
