categoria: Distruzione creativa
Nobel per l’Economia all’innovazione: è stata la scelta giusta?
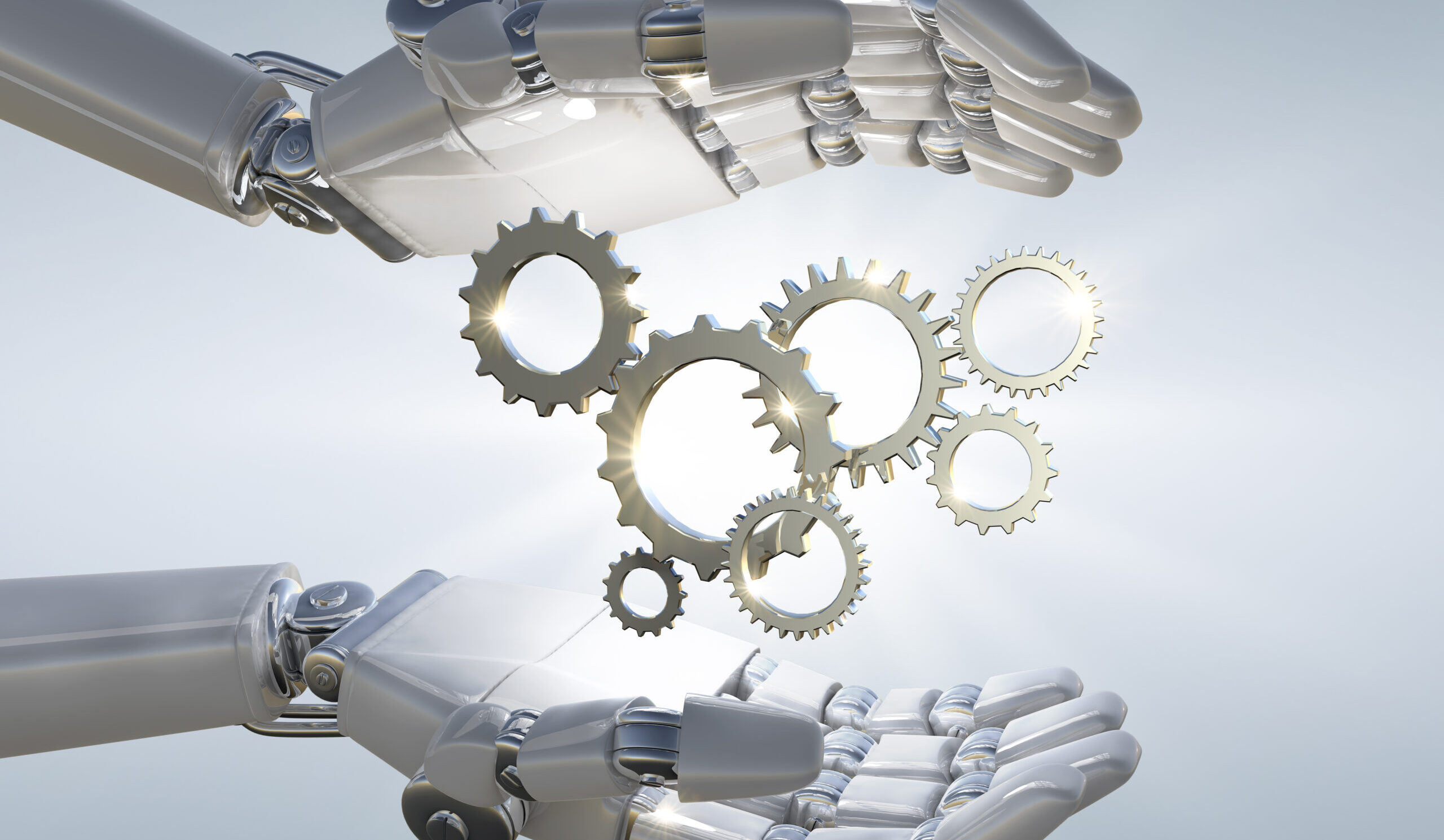
Premio Nobel per l’economia, scelta azzeccata? Proviamo a capirlo insieme.
Il premio Nobel è uno dei tanti riconoscimenti, in ambito scientifico, prestigioso e sicuramente il più famoso al mondo. Per questo ogni anno la curiosità è tanta, non solo nello scoprire il vincitore o i vincitori, ma anche, ammetto, nel confrontare i miei studi di “economics” con le teorie e ricerche appena premiate. L’esercizio non è sempre stato facile, non occupandomi di ricerca accademica pura nel mio lavoro. Questa volta, però, il compito è stato più agevole, poiché il tema mi ha sempre appassionato.
Quest’anno il premio Nobel è stato assegnato a tre autori, all’israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt. I tre accademici si sono occupati, in modo differente, del tema della crescita economica legata all’innovazione e come questa possa favorire un ulteriore progresso.
L’interessante approccio seguito dal primo si è concentrato sugli aspetti storici e culturali che caratterizzano la crescita economica. La storia è maestra di vita. Mokyr ha dedicato la sua intera carriera accademica allo studio dei fattori che hanno innescato la Rivoluzione industriale e, più ampiamente, favorito il progresso tecnologico del mondo occidentale.
Secondo la sua analisi, l’Europa moderna si è sviluppata grazie a una cultura basata sulla curiosità scientifica e la sperimentazione in un contesto alimentato da una fitta rete di scambi intellettuali senza trovare posizioni politiche di freno alla libertà di pensiero. Su questo aspetto, seguendo l’approccio dei premi Nobel precedenti, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, come sottolineavo nel mio precedente pezzo, la classe dirigente, volutamente o inconsapevolmente, ha fatto la differenza.
Gli altri due autori, Philippe Aghion e Peter Howitt, invece, hanno seguito un approccio quantitativo dando un importante contributo alla teoria della crescita endogena elaborando un modello di ispirazione schumpeteriana basato su tre pillar principali:
Meccanismo di Crescita: La crescita è vista come l’effetto del progresso tecnologico, il quale dipende a sua volta dalla concorrenza tra imprese che fanno ricerca e generano innovazioni.
Processo Innovativo: Ogni innovazione introduce un bene intermedio di tipo nuovo che permette di produrre l’output finale in condizioni di maggiore efficienza.
Incentivi e Monopolio: L’incentivo per l’impresa a impegnarsi nella ricerca è offerto dalla prospettiva di costruire delle rendite di monopolio grazie alla protezione legale delle innovazioni. Tuttavia, in un contesto dinamico, queste rendite vengono vanificate dalle innovazioni successive, che rendono obsoleto il bene intermedio appena prodotto (il concetto di distruzione creativa)
Gli studiosi hanno cercato di dimostrare che la conoscenza può essere accumulata dalle società attraverso numerosi canali, che vanno dall’istruzione formale fino alle innovazioni di prodotto. Ogni innovazione riuscita porta alla produzione di un bene intermedio di tipo nuovo, che permette di produrre l’output finale in condizioni di maggiore efficienza, quindi con un aumento della produttività.
Questo schema analitico evidenzia una forte relazione tra il potere di mercato dell’impresa e la sua capacità di proteggere la conoscenza che genera. Tale protezione dipende in modo critico da due fattori: la presenza di istituzioni legali (come i brevetti) e la natura stessa della conoscenza.
Ma il punto fondamentale, a mio parere, sta proprio nel fatto che gli studiosi hanno mostrato che la conoscenza, accumulata attraverso canali come l’istruzione formale e le innovazioni di prodotto, può essere un vero motore di crescita.
Questi temi sono cruciali e dovrebbero occupare la prima pagina dell’agenda di ogni governo e di ogni istituzione internazionale.
Non solo.
Sotteso a queste teorie e ragionamenti c’è il ruolo centrale dell’impresa o meglio degli imprenditori. E non è un caso, forse, che proprio in concomitanza con l’assegnazione del premio Nobel, si sia svolta l’Assemblea Generale di Assolombarda a Milano. L’intervento del presidente Alvise Biffi ha toccato, con una tempistica perfetta, gli stessi temi: la centralità della produttività e il ruolo cruciale dell’innovazione. In particolare, Biffi ha evidenziato come oggi siamo di fronte ad una nuova rivoluzione digitale, in cui l’intelligenza artificiale rappresenta l’unicità che insieme all’ investire in innovazione e qualità prodotti può consentire di vincere la competizione su scala internazionale.
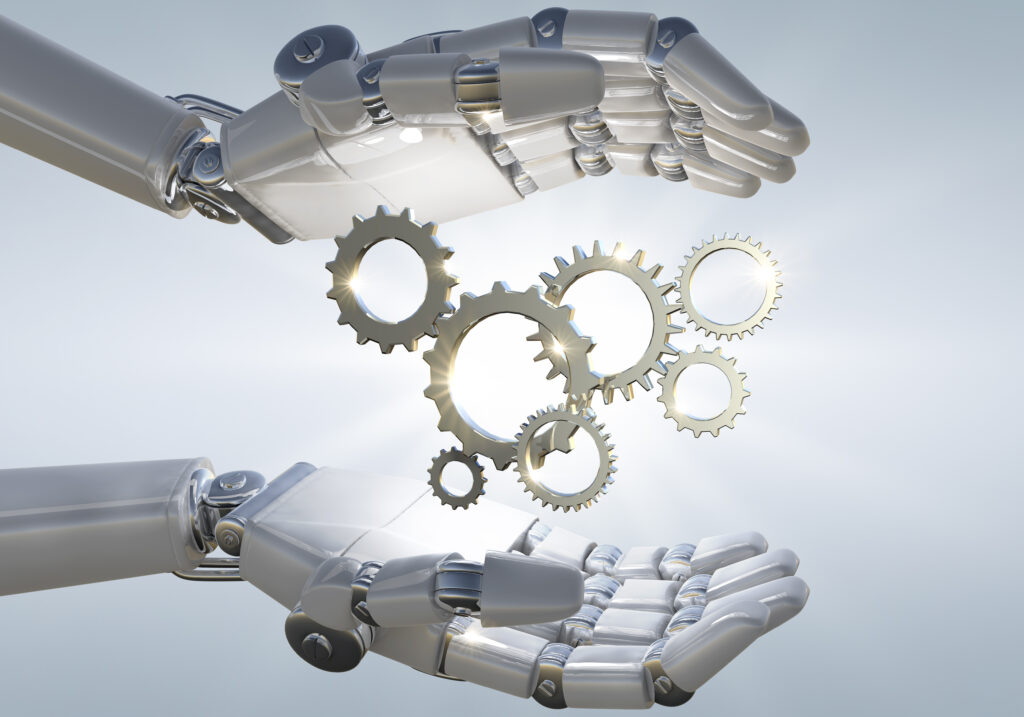
L’intelligenza artificiale rappresenta l’unicità che insieme all’ investire in innovazione e qualità dei prodotti permette di vincere la competizione su scala internazionale (immagine da Freepik)
Certamente il ruolo degli imprenditori è imprescindibile, come hanno giustamente evidenziato i nuovi premi Nobel per l’economia. Ma il vero cambio di paradigma lo si può avere solo con una sana collaborazione tra pubblico, come leva, e privato come risparmio ed imprenditoria.
Oggi serve investire negli asset intangibili (o nel “capitale intangibile”) per sprigionare il potenziale inespresso dall’innovazione delle nostre imprese, come evidenziato dai modelli di Aghion e Howitt. Ed infine, per assicurarci quel livello di prosperità tanto auspicato, il terzo elemento – indispensabile – spiegato bene da Mokyr, è rappresentato proprio dall’approccio della società al cambiamento. Quest’ultimo aspetto riguarda non solo l’apertura mentale, ma anche il senso critico – altrettanto indispensabile – per mitigare i nuovi rischi emergenti dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale.
Indubbiamente però, il nuovo futuro è già qui ed è questo il tempo di osare.
LinkedIn: @pasqualemerella
