categoria: Distruzione creativa
Sraffa e la tecnica senza lavoro: un’attualità inattesa
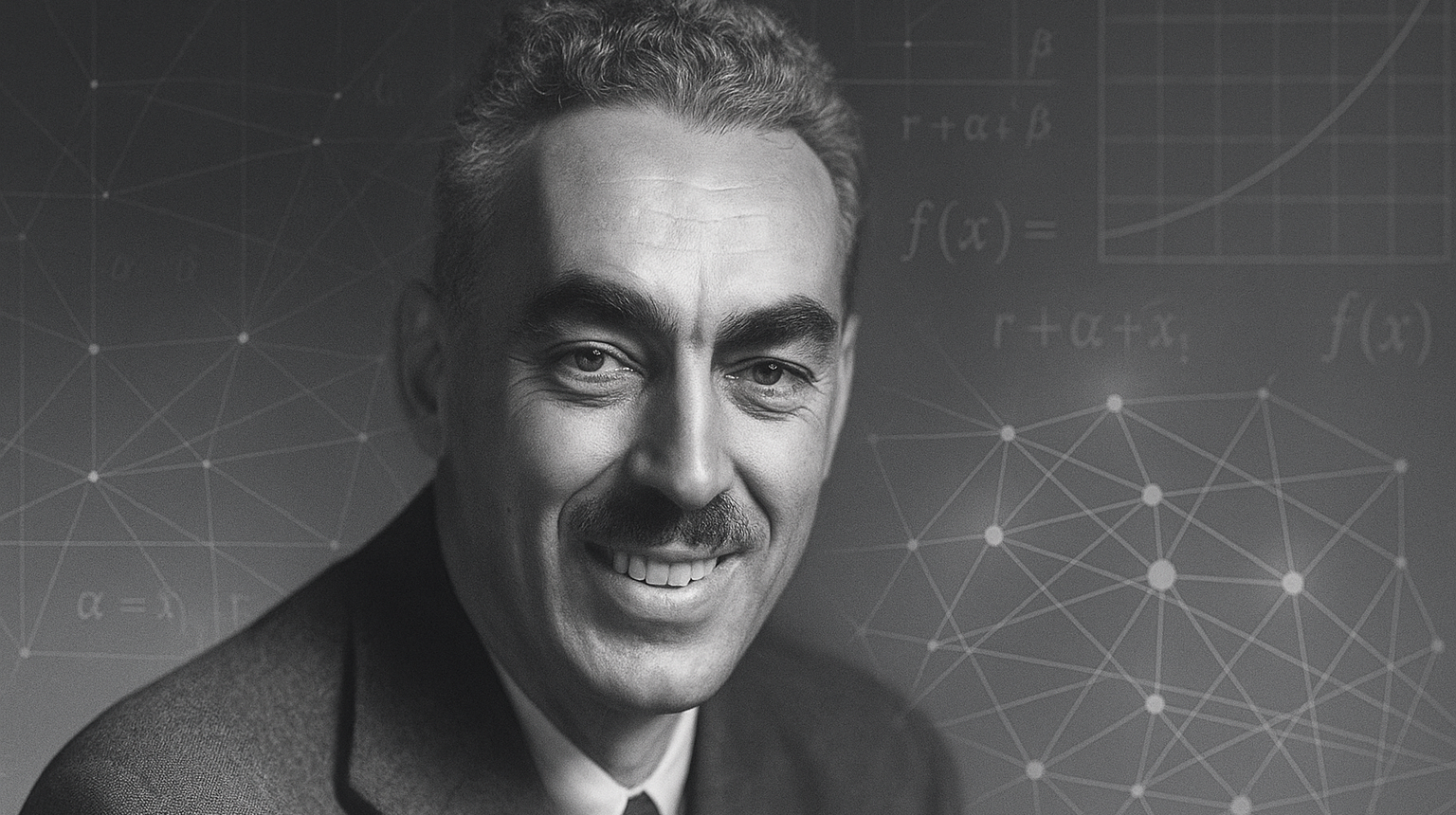
Post di Giovanni Di Corato, Amministratore Delegato Amundi RE Italia SGR* –
Molti intellettuali lasciano una scuola, altri, spesso battitori liberi, lasciano risposte che implicano nuove domande. Piero Sraffa appartiene a questa seconda specie: una figura elusiva, appartata, ciononostante capace di segnare in modo sotterraneo la storia del pensiero economico del Novecento. La sua opera principale — Production of Commodities by Means of Commodities (1960) — non ha lo stile dei manifesti teorici: è un libretto asciutto, quasi aforistico, scritto come un esercizio di logica pura.
Eppure, da quelle pagine, meno di cento, è uscita una delle più potenti demolizioni dell’edificio concettuale dell’economia moderna. Per capire di che cosa si tratta, bisogna tornare al “duello fra le due Cambridge”, l’inglese e l’americana, che dagli anni Trenta ai primi anni Sessanta, si fronteggiarono sul terreno più scivoloso della teoria economica: la determinazione del valore e della sua distribuzione.
Da una parte, a Cambridge (Massachusetts), l’economia neoclassica — Samuelson, Solow, gli epigoni della “sintesi keynesiana” — che fondava l’ordine del capitalismo moderno sull’eleganza delle funzioni di produzione, dove ciascun fattore riceveva un reddito proporzionale alla sua produttività marginale. Dall’altra, a Cambridge (Inghilterra), un gruppo di economisti eterodossi — Joan Robinson, Nicholas Kaldor, Luigi Pasinetti, e dietro di loro il silenzioso Sraffa — che mettevano in discussione proprio quella pretesa: l’idea che il valore e il reddito derivassero da leggi tecniche, e non da rapporti sociali e di potere.
Sraffa era arrivato a Cambridge nel 1927, dopo un esilio volontario dall’Italia fascista. Figlio di un giurista torinese, allievo di Pareto, era stato tra i giovani economisti che Beneduce e Mattioli avevano voluto accanto a sé nel cantiere della Banca Commerciale. Proprio Mattioli, che resterà un amico per tutta la vita, lo aiutò a lasciare l’Italia quando le sue simpatie socialiste e il suo rapporto con Antonio Gramsci, conosciuto ai tempi dell’università, lo misero sotto osservazione.
Fu Sraffa, a Londra, a procurare a Gramsci i libri e i materiali per i Quaderni del carcere, e Gramsci, nelle sue lettere, lo definiva “un uomo di straordinaria serietà e lealtà intellettuale”. A Cambridge, Sraffa trovò invece John Maynard Keynes, con cui instaurò un legame intellettuale oltre che di amicizia e di reciproca stima. Keynes lo coinvolse nella direzione dell’Economic Journal, e si fece stimolare dal suo scetticismo verso il marginalismo.
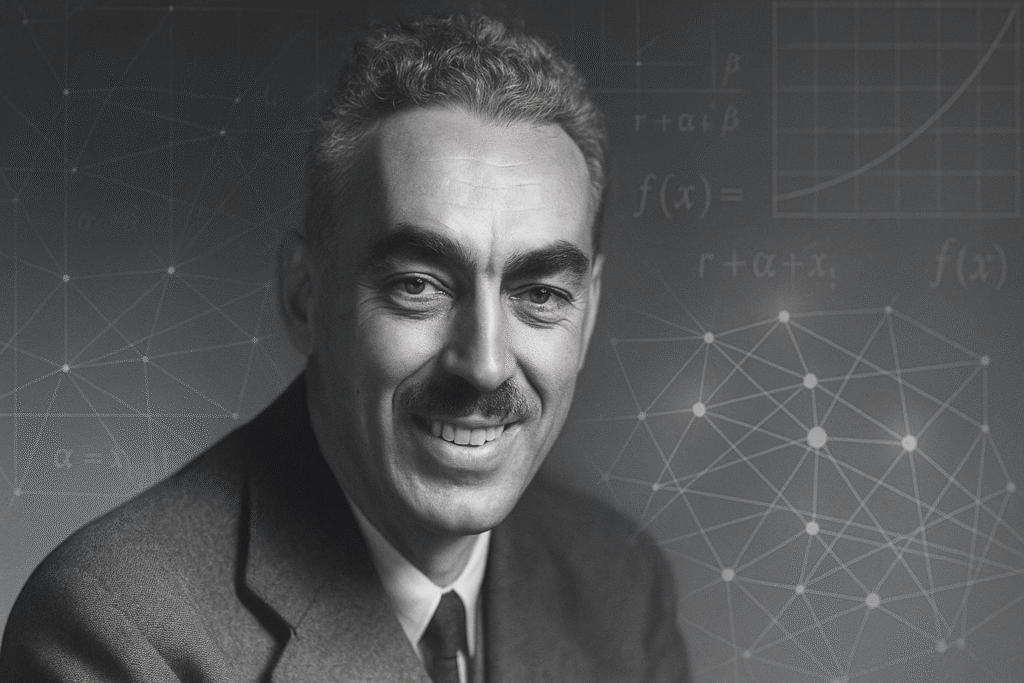
La lezione dell’economista Piero Sraffa torna attuale nell’epoca della tecnica senza lavoro (elaborazione grafica generata con IA)
È interessante ricordare che il Tract on Monetary Reform di Keynes e gli scritti giovanili di Sraffa condividono una critica alla nozione di equilibrio automatico dei mercati: entrambi sospettano che l’economia non sia un sistema che tende naturalmente alla piena occupazione, ma un ordine instabile e convenzionale, tenuto insieme da rapporti di forza e aspettative. Ma Sraffa, rispetto a Keynes, compie un passo ulteriore: se per Keynes il problema è la domanda effettiva, per Sraffa il problema è la misura del valore.
Dove Keynes mostra che il capitalismo può vivere sotto il suo potenziale per mancanza di spesa, Sraffa mostra che il modo stesso in cui calcoliamo i prezzi e i redditi è convenzionale, non tecnico. L’economia neoclassica cerca di far coincidere valore e produttività, salario e contributo marginale, reddito e merito. Sraffa rompe quel legame: il valore delle merci non dipende da quanto sono “produttivi” i fattori, ma da come si distribuisce il prodotto sociale fra di essi. È un problema di rapporti sociali, non di efficienza tecnica.
C’è in Sraffa un gusto quasi “filosofico” per la precisione logica — non a caso, il suo amico più caro fu Ludwig Wittgenstein, che lo considerava una delle menti più rigorose che avesse mai incontrato. Le loro conversazioni ruotavano attorno al linguaggio, alla logica e al significato dei concetti. È plausibile che da quel dialogo Sraffa abbia mutuato l’idea che i sistemi teorici non si confutano empiricamente, ma mostrandone le contraddizioni interne. Production of Commodities funziona infatti come un esperimento mentale wittgensteiniano: parte dal linguaggio stesso dell’economia classica per mostrarne l’incoerenza.
Nel modello di Sraffa, ogni merce è prodotta da altre merci e da una quantità di lavoro. Le condizioni tecniche sono date, e il sistema è in equilibrio stazionario. A quel punto si chiede: come si determinano i prezzi relativi e la distribuzione fra salari e profitti? E la risposta, semplice e devastante, è che il tasso di profitto e il livello dei salari non sono determinati tecnicamente, ma socialmente. La produttività spiega quanto si può produrre, ma non chi si appropria di che cosa. È la distribuzione — il rapporto tra capitale e lavoro, tra proprietà e forza lavoro — a determinare i prezzi di produzione, non il contrario.
Si può capire meglio con un esempio elementare. Immaginiamo due beni: pane e acciaio. Per produrre il pane serve molto lavoro umano e poca macchina; per produrre l’acciaio, invece, molta macchina e poco lavoro. Supponiamo che la tecnica resti identica, che non cambi nulla nei processi di produzione.
Eppure, se in questo sistema i salari aumentano e i profitti si riducono, diventa più costoso produrre pane, perché è un bene ad alta intensità di lavoro: il suo prezzo relativo sale rispetto all’acciaio. Se invece i salari scendono e i profitti aumentano, sarà l’acciaio a rincarare, perché il capitale “costa di più”. In entrambi i casi, i prezzi cambiano senza che la tecnica cambi: non dipendono da una maggiore o minore produttività, ma dalla distribuzione del reddito fra lavoro e capitale.
È questo il gesto teorico di Sraffa: scindere il valore dall’efficienza tecnica e restituirlo alla dimensione dei rapporti sociali e quando la contraddizione emerge, ciò che resta è una visione del capitalismo in cui la tecnica non fonda più la giustizia distributiva, ma ne è soltanto lo scenario. I prezzi sono la forma visibile di un rapporto di potere.
È per questo che, a Cambridge, Sraffa divenne una sorta di maestro silenzioso, venerato e temuto: non proponeva modelli alternativi, ma disarmava quelli esistenti. L’intuizione di Sraffa — che il valore non si determina tecnicamente ma socialmente — rimase a lungo confinata nei dipartimenti di economia teorica. Negli anni Sessanta, la sua lezione era già percepita come una sofisticazione logica, un episodio del “duello tra le due Cambridge”, utile per dimostrare i limiti del marginalismo ma difficile da tradurre in analisi macroeconomica.
In realtà, quella che sembrava una controversia accademica conteneva un germe che carsicamente sarebbe riemerso con insistenza nel campo dell’analisi economica: la separazione tra efficienza produttiva e giustificazione della distribuzione. Il mondo che Sraffa aveva davanti agli occhi era ancora un capitalismo industriale, fondato sul lavoro e sul capitale fisico.
Oggi, invece, viviamo dentro un capitalismo cognitivo, in cui la tecnica, a maggior ragione con l’avvento dell’intelligenza artificiale, sembra poter assorbire interamente la produttività e proprio per questo, paradossalmente, la sua intuizione appare diventare estremamente attuale.
Il pensiero economico dominante ha sempre cercato di far dipendere strettamente il prezzo, quindi il valore, della produttività marginale dei fattori. L’idea che ciascun fattore sia remunerato secondo il proprio contributo alla produzione è il fondamento morale e politico dell’economia neoclassica. Sraffa aveva smontato quella pretesa nel suo laboratorio teorico: dimostrando che, dati i coefficienti tecnici di produzione, il prezzo relativo delle merci dipende dal rapporto fra salari e profitti, non dal contributo “oggettivo” di ciascun fattore. La tecnica fissa solo le possibilità fisiche del sistema, non le proporzioni distributive.
Se riprendiamo questo schema e lo applichiamo alla fase attuale, vediamo che l’“economia dell’intelligenza artificiale” ne è la versione estrema e paradossale. Qui la produttività dei fattori non solo non spiega più la distribuzione, ma tende a cancellare uno dei fattori — il lavoro umano. Il capitale cognitivo, nella forma dei modelli, delle reti e delle infrastrutture di calcolo, si presenta come fattore assoluto, in grado, almeno potenzialmente, di produrre valore autonomamente senza contributo del lavoro.
In un certo senso, l’IA mette in scena ciò che Sraffa aveva solo intuito sul piano teorico: un’economia in cui la tecnica non ha più una funzione distributiva, ma soltanto una funzione abilitante. La produzione continua — e anzi cresce — ma il criterio di distribuzione del prodotto diventa puramente politico e proprietario. Il lavoro, potenzialmente, non ha più alcun ruolo a determinare la misura del valore, strettamente dipendente, invece, dalla gerarchia delle infrastrutture. Chi controlla i data center, i modelli, i flussi di energia e di informazione si appropria della totalità del surplus. In questa prospettiva, il pensiero di Sraffa anticipa l’economia delle piattaforme e, più in generale, del capitalismo digitale.
La logica è identica: il valore non è un riflesso della produttività tecnica, ma il risultato di una distribuzione asimmetrica del potere d’accesso. Che si tratti di merci prodotte da merci o di cognizioni prodotte da cognizioni, ciò che conta non è la relazione tecnica tra input e output, ma la struttura proprietaria che regola quella relazione.
L’IA radicalizza il paradosso: il lavoro non scompare per mancanza di efficienza, ma per eccesso di produttività del capitale capace, ipoteticamente, di generare una capacità produttiva illimitata. La stessa forma del valore tende così a disancorarsi da ogni misura oggettiva. Nel momento in cui la produttività non incontra più un limite umano, il valore non può più essere definito da un costo o da una fatica: diventa una pura funzione di distribuzione del potere.
È qui che la lezione di Sraffa torna a pulsare sotto la superficie del presente. La sua critica, nata per smontare il legame ideologico tra produttività e giustizia distributiva, ci offre oggi una chiave per leggere un capitalismo in cui la produttività delle macchine è destinata a rendersi autonoma e la dimensione distributiva con il lavoro, sostanzialmente, a scomparire dall’equazione.
L’intuizione sraffiana è forse la sola che permetta di comprendere ciò che sta accadendo nell’economia dell’intelligenza artificiale. La logica del valore è tornata a essere distributiva in senso puro in un contesto in cui la combinazione — produttività assoluta e distribuzione concentrata — è la cifra del capitalismo cognitivo nascente.
L’IA, nella sua fase attuale, è ancora lontana dall’essere una tecnologia matura: siamo alla sua infanzia industriale, come lo eravamo nel 1985 per il personal computer o nel 1900 per l’elettrificazione. Eppure, i mercati finanziari ne prezzano già l’esito finale, non il presente: valutano le imprese come se fossero già in possesso della chiave produttiva di tutto ciò che può essere automatizzato, scritto, progettato o previsto.
In apparenza, questa valutazione è irrazionale; in realtà, esprime una anticipazione perfettamente coerente con la logica del capitale. Il mercato non scommette sui profitti attuali, ma sul fatto che, se la produttività diventa illimitata e il lavoro umano marginale, il valore non avrà più misura e potenzialmente potrebbe essere infinito.
In termini sraffiani, si tratta di un sistema in cui il tasso di profitto cresce indipendentemente dai vincoli tecnici, poiché la tecnica non incontra più limiti di costo marginale. Una volta che il lavoro vivo tende a zero, ciò che si espande non è tanto la produzione materiale, quanto la quota di valore che il capitale tecnologico riesce a catturare. Il profitto, da variabile di equilibrio, diventa una variabile di potere.
Il valore cresce non perché aumenti la ricchezza complessiva della collettività, ma perché si concentra sempre di più in chi controlla la tecnologia. È un valore che tende a perdere la misura dal momento che non ha più un limite sociale o distributivo. In assenza di vincoli politici, salariali o concorrenziali, il capitale tecnologico, in un contesto iper-oligopolistico in cui il prezzo lo fa il produttore, può appropriarsi dell’intero surplus il valore cessa di avere una misura condivisa.
Tuttavia, questa dinamica può reggersi soltanto in una fase di espansione ipertrofica dell’infrastruttura. Finché l’IA richiede enormi investimenti in data center, energia, chip e connettività, il sistema resta macroeconomicamente sostenibile: la quota salari si comprime, ma la domanda aggregata è alimentata dalla crescita del capitale fisso.
L’espansione degli investimenti — pubblici e privati — compensa la contrazione dei redditi da lavoro, e il capitalismo cognitivo può mantenere una traiettoria espansiva apparentemente autonoma, “autofertilizzante”. È un equilibrio instabile ma reale: la riproduzione tecnica sopravvive perché la riproduzione infrastrutturale ne sostiene la domanda. Una replica tecnologica del modello di sviluppo cinese degli ultimi decenni: consumi ultra-compressi e investimenti colossali.
In questa fase, il valore dell’IA appare potenzialmente infinito perché la produttività cresce senza limiti apparenti e perché la distribuzione non ha ancora incontrato il suo vincolo politico. Il sistema si regge su un paradosso: una concentrazione estrema della distribuzione che, finché richiede investimenti crescenti, continua a generare espansione. È un capitalismo di frontiera, nel quale la polarizzazione diseguale del reddito non è ancora recessiva, ma propulsiva.
Il problema sorge quando la curva di investimento si appiattisce, quando l’infrastruttura raggiunge la scala ottimale e la tecnologia comincia a vivere della sua stressa rendita. A quel punto, la compressione salariale non è più compensata dalla spesa in capitale, e l’economia entra in una fase di riproduzione impossibile: il sistema può ancora produrre merci (o cognizioni) a mezzo di merci, ma non riesce più a riprodurre le condizioni sociali della propria domanda. La produttività continua a crescere, ma il valore realizzabile si restringe.
È la stessa contraddizione che Sraffa aveva lasciato intuire nel suo modello stazionario e che i post-keynesiani — da Kalecki a Garegnani — tradussero in termini macroeconomici: la distribuzione è una variabile sociale prima ancora che economica; spingerla troppo verso i profitti significa distruggere la base della riproduzione. Da questo punto di vista, l’economia dell’IA è la realizzazione storica di un modello teorico: un sistema in cui la produzione può moltiplicarsi indefinitamente, ma il valore si dissolve nel momento in cui non incontra più un criterio di distribuzione sostenibile.
L’infinito che promette è reale soltanto finché resta un infinito in costruzione, cioè finché richiede investimenti crescenti e un’espansione fisica del capitale cognitivo. Quando questa crescita si arresta, il valore smette di avere misura: i rapporti di produzione non consentono più una redistribuzione fisiologica del reddito.
Il limite del modello di Sraffa è lo stesso che ne costituisce la forza: la sua staticità. Nel rappresentare l’economia come un sistema chiuso di riproduzione — merci a mezzo di merci — Sraffa blocca la dinamica storica del conflitto fra capitale e lavoro. Quel conflitto resta dato, esterno alla teoria, come un parametro distributivo. È un modo per mostrare che, anche in un equilibrio perfetto e immobile, la distribuzione non si determina tecnicamente ma politicamente. In questo senso, il suo schema può essere letto come una forma anticipata di ciò che oggi si manifesta nella realtà: un’economia in cui la riproduzione tecnica tende a sostituirsi alla riproduzione sociale.
Nel capitalismo cognitivo che si sta formando intorno all’intelligenza artificiale, quella struttura diventa pienamente riconoscibile: la produzione procede per conto proprio, il valore si accumula come differenziale di potere, e la riproduzione sociale diventa una variabile residuale, eventualmente affidata a politiche pubbliche di compensazione o a un credito illimitato.
In questa logica, la macchina non sostituisce solo il lavoro: sostituisce il nesso tra produzione e riproduzione che teneva in piedi la società industriale. Finché l’espansione infrastrutturale dell’IA richiede investimenti crescenti, l’equilibrio si regge — ma nel momento in cui la tecnologia diventa autosufficiente, il circuito si chiude e la domanda effettiva scompare. Non è un problema tecnico: è una questione distributiva, nel senso più sraffiano del termine. Il capitale cognitivo può continuare a produrre “merci” — testi, modelli, decisioni, simulazioni — ma senza un salario, senza consumo e senza tempo sociale, il valore non trova più un luogo in cui realizzarsi.
Sraffa aveva mostrato che i prezzi di produzione dipendono dalla distribuzione del reddito, non viceversa; il capitalismo dell’IA lo conferma su scala globale. Non è la produttività della macchina a determinare il valore, ma la forma di appropriazione che l’accompagna.
La concentrazione del capitale cognitivo in poche mani non è un esito accidentale, ma la condizione stessa della sua valorizzazione. Il valore tende all’infinito solo perché tende a essere interamente privatizzato: infinito perché privo di misura comune. Il giorno in cui la collettività non partecipa più alla distribuzione, l’infinito non è più crescita — è implosione. Il punto, allora, non è chiedersi se l’IA distruggerà il lavoro, ma quale ordine distributivo potrà sostituirlo.
La sua intuizione che il valore è un fatto politico, non tecnico, diventa oggi una diagnosi antropologica: la tecnica non ha più bisogno del lavoro, ma la società ha bisogno di un reddito. Sraffa che praticamente non pubblicò nulla oltre al testo citato, consapevole forse che “di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere”, ci obbliga a ricordare che il problema economico non è mai tecnico, ma distributivo e che ogni volta che il capitalismo dimentica questa verità, si prepara a costruire un eccesso destinato, prima o poi, probabilmente più poi che prima, visto che siamo ancora agli albori dell’IA, ad implodere.
*Le opinioni qui espresse sono di esclusiva responsabilità dell’autore
