categoria: Distruzione creativa
L’autonomia è un progetto di design: il ruolo della leadership tra persone e intelligenze artificiali

Post di Tomas Barazza, founder della tech company Wethod
C’è una sottile linea che separa l’autonomia dall’irrilevanza. In diversi ambiti – familiare, lavorativo o tecnologico – cerchiamo spesso di rendere ciò che costruiamo capace di camminare da solo. Quante volte le indicazioni date a figli e colleghi non sono semplici direzioni da seguire, ma consigli per stimolare la crescita dei nostri interlocutori e far sì che, con il tempo, possano acquisire maggiore libertà decisionale?
Ma una volta raggiunto l’obiettivo sorge una domanda inaspettata, non contemplata fino a quel momento: “e ora, a cosa servo io?”. Succede con i figli che crescono e iniziano a fare scelte indipendenti, ma succede anche con i propri team in azienda che, dopo anni di lavoro e di fiducia, imparano a procedere senza il nostro intervento. E oggi sta succedendo sempre più con gli AI Agents: i sistemi che apprendono, decidono e agiscono in autonomia.
In tutti questi casi, la concessione di autonomia si manifesta come una conquista perché rappresenta la fine del controllo come misura del valore – siamo orgogliosi di vedere che tutto fili liscio anche senza di noi – ma fa emergere una domanda più profonda: che fine fa la nostra rilevanza?
E se è la tecnologia a diventare indipendente?
Questa stessa logica si sta estendendo al mondo delle tecnologie intelligenti. Gli AI Agents non sono più strumenti passivi: il progresso generato da noi esseri umani ha portato all’ideazione di strumenti che, una volta ricevuto un obiettivo, possono agire in più fasi per raggiungerlo – elaborando un piano, eseguendolo e imparando dal risultato ottenuto. Sono, di fatto, collaboratori digitali che prendono decisioni e producono valore: possono raccogliere dati, combinarli, formulare analisi articolate e, sempre più spesso, svolgere compiti che fino a poco tempo fa necessitavano di avanzate competenze umane. La differenza rispetto alle automazioni tradizionali è enorme: con le tecnologie odierne l’autonomia non è programmata, perché l’agente non si limita a eseguire istruzioni, ma sceglie la strategia.
E più questi sistemi diventano capaci di agire e dare un seguito alle sempre più complesse richieste umane, più si ripropone la domanda: cosa resta di umano in questo processo? Cosa resta della conoscenza e della creatività delle persone?
Con l’ingresso degli AI Agents nel dibattito sull’autonomia, il concetto di “agire per conto proprio” acquista una nuova dimensione: stimolante per molte aziende, ma potenzialmente fonte di incertezza per i lavoratori. È una rivoluzione silenziosa già in atto per molte organizzazioni e figure professionali. Si pensi ad esempio ai programmatori, che possono coordinare squadre di agenti che scrivono codici al posto loro, o agli avvocati che sono oggi nella condizione di delegare all’AI attività finora appannaggio delle figure junior.
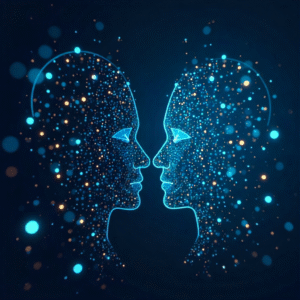
AI Agents (immagine da Freepik)
Il rischio per le figure junior di oggi e le figure senior di domani
Quest’ultimo esempio apre a un discorso assolutamente necessario da affrontare quando si parla di futuro del lavoro: quasi tutte le attività fondamentali nel percorso formativo dei giovani possono ora essere svolte da sistemi di intelligenza artificiale. Dietro questa ricerca di efficienza dobbiamo chiederci: che ne sarà della crescita professionale delle figure junior, se le attività di base – quelle che tradizionalmente insegnano metodo, linguaggio e pensiero – vengono delegate alle macchine?
Il rischio è quello di interrompere la filiera della competenza: senza il tempo dell’apprendistato, non ci saranno i senior di domani. Per questo, la domanda non è se adottare gli agenti intelligenti, ma come integrarli senza svuotare i percorsi di apprendimento. L’efficienza che offrono è impressionante, ma non può sostituire il valore dell’errore e della pratica quotidiana dei junior. Anche perché senza i junior di oggi, non ci saranno i senior di domani.
Serve quindi ripensare il concetto stesso di formazione: se la prima esperienza lavorativa diventa sempre più mediata dalla tecnologia, allora l’apprendimento deve iniziare prima, a scuola o in contesti formativi evoluti, dove si impari non solo a usare l’intelligenza artificiale, ma a comprenderla e governarla. Solo così le nuove generazioni potranno crescere accanto agli agenti digitali senza smettere di sviluppare la competenza più preziosa: quella che nasce dalla consapevolezza del proprio ruolo nel sistema.
Il futuro della leadership nella progettazione dell’autonomia
Per ovviare al problema dell’eccesso di autonomia dei sistemi di AI – questi “lavoratori digitali instancabili” che rischiano di cancellare in toto un numero elevato di posti di lavoro, impedendo la formazione sul campo dei professionisti del futuro – la soluzione sta nelle decisioni intraprese dalla leadership, nel design dell’autonomia stessa.
Progettare autonomia non significa semplicemente “lasciare andare”: significa disegnare un sistema di relazioni in cui la libertà di uno non si traduce nella sparizione dell’altro. Chi guida persone – o cresce figli – conosce bene questa tensione: l’obiettivo è rendere l’altro capace di agire da sé, ma senza che questo comporti una perdita di legame, di direzione o di significato. Nel lavoro vale lo stesso discorso: un team davvero autonomo non è un gruppo che fa tutto da solo, ma una comunità che sa decidere in modo coerente anche in assenza del leader. Idem per gli AI Agents, la cui autonomia rischia di ritorcersi contro l’azienda (e il mondo del lavoro in generale) se non progettata e guidata secondo la visione d’insieme di un leader umano.
Infatti l’autonomia, se non è accompagnata da senso condiviso e visione, rischia di trasformarsi in dispersione. Essere leader in un contesto autonomo significa passare dall’essere decisore all’essere curatore del sistema – è una forma di design invisibile, che lavora sulla cultura più che sulle procedure.
Che si tratti di persone o di macchine, il punto resta lo stesso: l’autonomia si può concedere solo se è stata prima progettata. Un sistema autonomo non è un sistema libero da regole, ma uno in cui le regole sono state pensate per generare libertà. Nel design organizzativo, questo significa costruire infrastrutture culturali solide in azienda: valori, procedure, strumenti che garantiscono coerenza anche quando il leader non è nella stanza. Mentre nel design tecnologico significa definire limiti e scopi chiari, perché l’autonomia delle macchine non si trasformi in opacità di visione in nome dell’efficienza.
Il futuro della leadership sarà quindi meno legato al controllo e più alla capacità di creare ecosistemi auto-organizzanti. Chi guida dovrà saper coltivare fiducia anziché limitarsi a dare istruzioni, e accettare che il proprio ruolo non è eterno, ma evolutivo. Alla fine, generare autonomia ridefinisce (non cancella) il valore di chi l’ha progettata e concessa: un genitore resta punto di riferimento anche quando il figlio è lontano, e un leader resta guida anche quando il team sa camminare da solo.
