categoria: Econopoly
Dai flussi allo stock: la riforma fiscale necessaria di cui nessuno parla
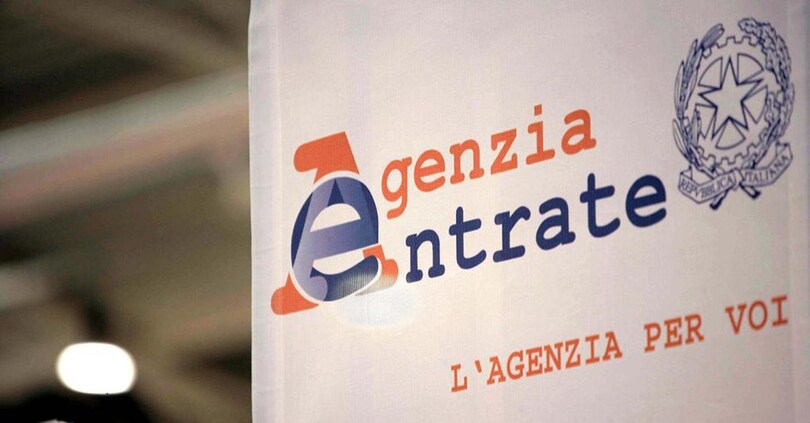
Post di Giovanni Federico Di Corato, CEO di Amundi Real Estate Italia SGR *
Il dibattito fiscale italiano, mentre procede la discussione sulla legge di bilancio, continua a muoversi in una povertà concettuale sorprendente. La discussione si concentra quasi solo sulle aliquote dell’IRPEF, come se la progressività dell’intero sistema dipendesse dagli scaglioni applicati ai soli redditi ad esse assoggettate, sostanzialmente, nei numeri, quelli originati da lavoro dipendente. Nel frattempo, però, una parte crescente dei redditi sfugge alla modulazione delle aliquote IRPEF: i redditi finanziari e immobiliari sono tassati attraverso imposte sostitutive proporzionali, mentre per il lavoro autonomo si sono moltiplicati regimi agevolati che introducono di fatto una flat tax selettiva. Il risultato è un sistema in cui contribuenti con redditi simili ma con inquadramenti diversi pagano imposte profondamente differenti. La progressività formale resta sulla carta; quella sostanziale si dissolve nella frammentazione.
Peraltro, nel campo dell’opposizione, la patrimoniale viene agitata come un feticcio identitario, spesso con una valenza più morale che economica, come se “tassare i ricchi” potesse costituire un progetto riformatore. Ne deriva un confronto privo di struttura, in cui ogni parte difende un simbolo più che interrogarsi sui meccanismi che determinano chi paga cosa, perché lo paga e soprattutto quali incentivi produce il sistema nel suo complesso.
La questione centrale dovrebbe essere affrontata in termini diversi. In un’economia caratterizzata da demografia stagnante, forte patrimonializzazione privata e produttività che da anni cresce troppo poco, il vero problema è che il fisco italiano tassa eccessivamente il lavoro e l’attività d’impresa, mentre colpisce in modo debole, frammentario o incoerente la ricchezza accumulata e le rendite, sostenendo questa asimmetria con la presunta illegittimità e disfunzionalità – sempre più contraddetta dai fatti – della cosiddetta doppia tassazione del reddito. Da qui discende un’asimmetria profonda negli incentivi: conviene preservare la rendita piuttosto che impegnarsi in attività produttive.
Una riforma fiscale coerente con le esigenze del tempo dovrebbe partire da un’idea semplice: i flussi vanno liberati, lo stock va ordinatamente tassato. In altre parole, il prelievo dovrebbe essere spostato dal lavoro e dai profitti – che generano valore, occupazione e crescita – verso la ricchezza già formata, che oggi contribuisce al gettito in modo tanto disomogeneo quanto limitato. Ciò implicherebbe non solo una riduzione significativa dell’imposizione diretta sul reddito d’impresa e sul reddito da lavoro, ma anche l’abolizione della tassazione sui flussi di reddito generati dal patrimonio investito – dividendi, interessi, affitti, plusvalenze – che rappresentano una parte marginale del gettito esprimendo, data la variabilità delle aliquote in quel campo, anche un effetto distorsivo. In una simile prospettiva, il principio guida diventa immediato: ciò che produce valore non deve essere frenato, mentre la ricchezza accumulata deve essere il perno di un prelievo stabile, trasparente e coerente. Il sistema fiscale distinguerebbe in modo molto netto tra “forze produttive messe al lavoro” e capitale che resta inerte, rendendo evidente la ricomposizione del baricentro fiscale dai flussi allo stock.
La fattibilità di un simile cambiamento, che a prima vista potrebbe apparire radicale, emerge con chiarezza se si considerano le grandezze macroeconomiche. Le famiglie italiane dispongono di un patrimonio netto mobiliare e immobiliare di 11.700 miliardi di euro, oltre cinque volte il PIL annuale. La sola ricchezza finanziaria ha raggiunto i 6.000 miliardi. È a questo stock che va rapportata qualsiasi ipotesi di spostamento del baricentro fiscale. Il PIL italiano ammonta a circa 2.200 miliardi di euro, nel quadro di una pressione fiscale complessiva pari al 42,6% del PIL, il peso delle sole imposte dirette, al netto dei contributi, è pari al 16%. Ridurre di cinque punti di PIL le imposte dirette, comprimendo di circa il 31% il gettito da esse generato, detassando pesantemente redditi da lavoro e d’impresa e azzerando la tassazione sui redditi generati da investimenti mobiliari e immobiliari, comporterebbe una perdita di gettito nell’ordine dei 110 miliardi l’anno. Una cifra che, considerata a sé stante, appare proibitiva.
Eppure, rapportata a una base patrimoniale prossima a 12.000 miliardi, quella cifra cambia totalmente scala: una patrimoniale piatta dell’1,0% basterebbe a compensare interamente quel fabbisogno. Non il tre per cento, non il cinque: circa l’un per cento annuo. Evidentemente ciò costituisce un ordine di grandezza non un programma. Ma è sufficiente a mostrare che una patrimoniale sistemica può “stare in piedi” quando il patrimonio complessivo è molto ampio.
Qui il riferimento alla Svizzera diventa istruttivo. La Svizzera applica da decenni una patrimoniale ordinaria sulla ricchezza netta delle persone fisiche: un’imposta annuale prelevata a livello cantonale e comunale, calcolata sul patrimonio netto (attività meno passività) con aliquote che vanno dallo 0,1 allo 0,5%, con punte intorno all’1% in alcuni cantoni. Gli immobili sono tassati a valori catastali inferiori ai valori di mercato, gli asset finanziari al valore nominale, e l’imposta genera ogni anno circa l’1% del PIL svizzero. Si tratta di una piccola prova empirica che una patrimoniale sistemica, quando è moderata e stabile, è compatibile con un’economia aperta, competitiva e attrattiva. Non è un modello da imitare in ogni dettaglio, ma la dimostrazione che ciò che in Italia viene percepito come impossibile altrove è semplicemente normale amministrazione.
A questo punto la questione diventa propriamente strategica. Una patrimoniale generale, non pensata come soluzione redistributiva a titolo di “risarcimento” a carico di ricchi e super-ricchi, avrebbe senso solo se contribuisse a orientare la struttura economica del Paese. Il suo disegno dovrebbe prevedere che la ricchezza improduttiva contribuisca stabilmente, mentre quella impiegata in attività che rafforzano la base produttiva venga agevolata o esentata. In pratica ciò significherebbe rendere sempre meno conveniente detenere patrimonio inerte e sempre più conveniente investirlo in ciò che genera crescita. Per esempio, gli investimenti che sostengono l’innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la trasformazione energetica e la coesione sociale – dai fondi di venture capital a quelli di private equity orientati all’aggregazione delle PMI, dai fondi infrastrutturali dedicati alla transizione energetica ai veicoli destinati al social housing – rappresentano esattamente il tipo di capitale che andrebbe sottratto all’imposta patrimoniale.
È solo dopo aver chiarito questo principio che diventa utile richiamare il caso israeliano. All’inizio degli anni Novanta, Israele non era in alcun modo la “startup nation” di oggi: il venture capital era quasi inesistente, la produttività stagnante, l’ecosistema tecnologico embrionale. Con il programma Yozma, lo Stato scelse di intervenire direttamente nell’orientare il risparmio nazionale. Offrì co-investimenti pubblici, garanzie e pesanti vantaggi fiscali a chi investiva nelle prime fasi delle imprese tecnologiche. Nel giro di pochi anni si sviluppò un ecosistema pubblico-privato di fondi di venture capital che trasformò strutturalmente la composizione del capitale investito nel Paese, dando vita a una delle industrie tecnologiche più dinamiche al mondo. Il punto non è imitare Yozma, ma riconoscere che una politica fiscale orientata, stabile e coerente può mobilitare il capitale privato verso settori ad alta produttività. Il fisco, in questa prospettiva, smette di essere un mero meccanismo di prelievo e diventa un mezzo per indirizzare gli investimenti verso ciò che costruisce il futuro.
Tutto ciò richiederebbe anche una distinzione netta tra patrimonio essenziale non imponibile e patrimonio imponibile. Il risparmio di “sussistenza” ed in particolare la prima casa che non genera rendita e non è mobilizzabile, non può essere assimilato ad un generico asset finanziario o immobiliare. Per questo qualsiasi percorso riformatore che puntasse ad una patrimoniale generale dovrebbe prevedere soglie di esenzione per i piccoli patrimoni e una tutela esplicita dell’abitazione principale. Solo così la patrimoniale potrebbe contribuire alla crescita senza gravare su ciò che rappresenta una necessità familiare e sostanzialmente un implicito ammortizzatore sociale.
Ciò che qui si evoca non è uno switch improvviso di cinque punti di PIL del carico fiscale dai redditi ai patrimoni, né potrebbe esserlo, bensì un percorso: un avvicinamento progressivo, costruito passo dopo passo, in cui l’alleggerimento della tassazione sui flussi sarebbe accompagnato da un affinamento di una patrimoniale generale, delle sue esenzioni e dei suoi incentivi. Anche solo un movimento iniziale, marginale rispetto a quella soglia teorica, costituirebbe un salto di qualità enorme rispetto al nulla che il Paese ha fatto negli ultimi decenni in materia di riforma fiscale. La riforma non starebbe nel raggiungimento immediato del traguardo, ma nell’aver finalmente imboccato la direzione giusta.
Vista sotto questa prospettiva il termine patrimoniale smette di essere radicale e diventa semplicemente razionale: meno tasse sul lavoro, meno tasse sui profitti, zero tasse sui flussi da capitale, una patrimoniale moderata e diffusa sulla ricchezza netta, incentivi per la mobilitazione del capitale produttivo e tutela dei patrimoni essenziali. È un ribaltamento logico: ciò che genera valore viene premiato, ciò che resta inattivo contribuisce in modo proporzionato. Il lavoro e l’impresa respirano; il patrimonio paga un contributo stabile; il capitale produttivo viene favorito rispetto a quello immobilizzato.
Il dibattito italiano, impigliato da anni nella contabilità degli scaglioni e nelle caricature della patrimoniale, difficilmente riesce a immaginare un modello di questo tipo. Eppure, anche un primo passo verso questa direzione costituirebbe una riforma più profonda di qualsiasi operazione simbolica discussa negli ultimi trent’anni. Si tratterebbe di una conversione culturale, prima ancora che tecnica. E, proprio per questo, potrebbe finalmente mettere ordine dove oggi regna soprattutto confusione.
*Le opinioni qui espresse sono di esclusiva responsabilità dell’autore
