categoria: Sistema solare
La Cina non copia più. Guida. E l’Occidente deve adattarsi
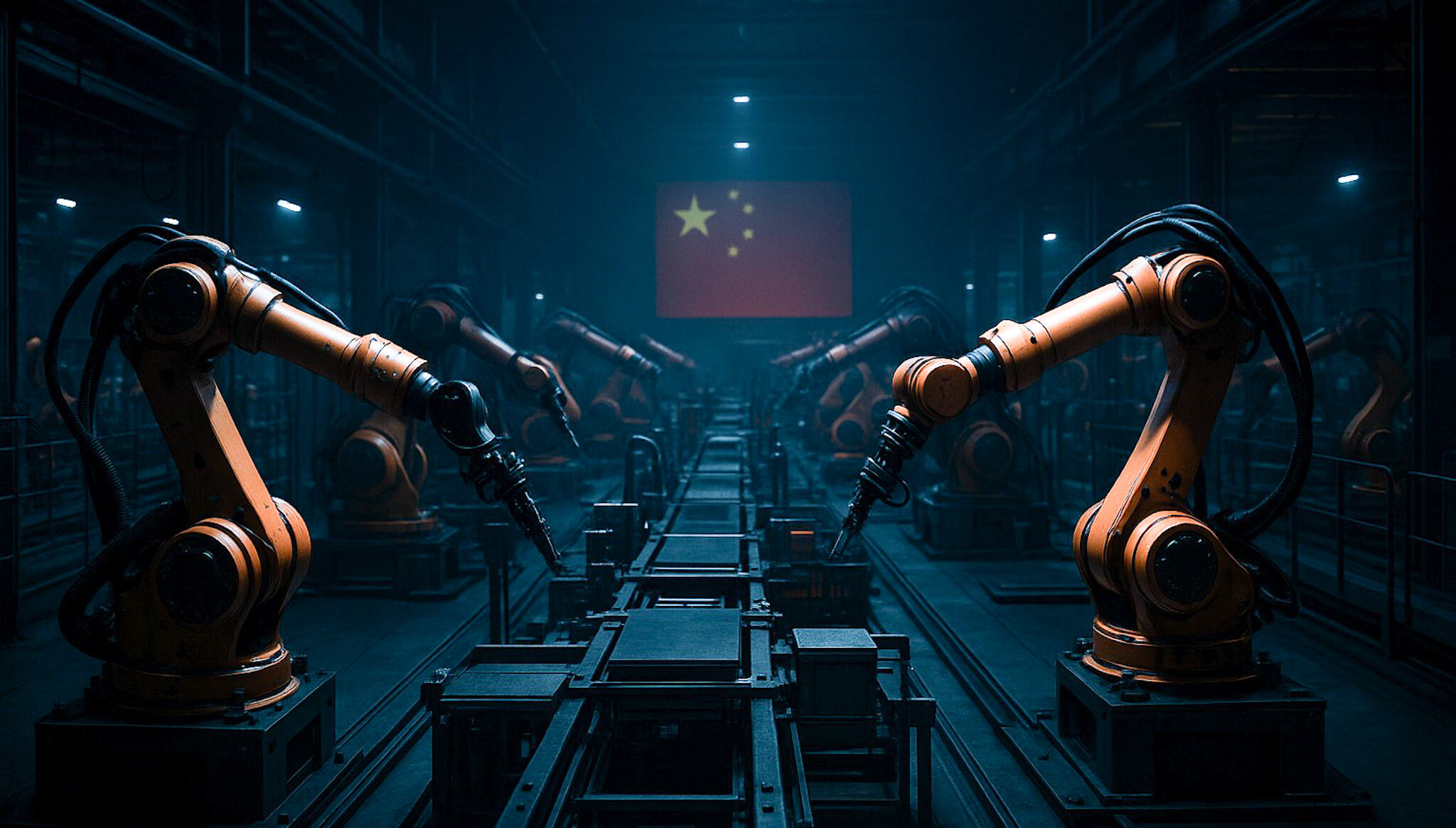
Post di Omar Rachedi, Professore Associato, Dipartimento di Economia, Finanza e Contabilità, Esade –
In uno stabilimento automatizzato della Xiaomi, situato nel distretto di Changping a Pechino, le luci restano spente, ma la produzione non si ferma mai — nemmeno per un secondo. Questa smart factory è in grado di produrre fino a 10 milioni di smartphone all’anno, al ritmo impressionante di uno al secondo. Robot e sensori interconnessi, alimentati dall’intelligenza artificiale, assemblano componenti elettronici complessi senza necessità di supervisione umana. Uno scenario che sembrerebbe tratto da un romanzo di fantascienza è oggi realtà industriale: le cosiddette dark factories.
La Cina non è più soltanto la fabbrica del mondo; è diventata uno dei principali laboratori di innovazione a livello globale. Non si limita più a inseguire: in molti settori tecnologici, detta ormai il passo. Per anni è stata accusata di adottare tattiche aggressive per appropriarsi della proprietà intellettuale occidentale — dalle copie dei brevetti all’imposizione di joint venture obbligatorie per accedere al suo mercato. Ma quella fase sta lasciando spazio a una nuova realtà: quella di un Paese che oggi genera innovazione propria a velocità vertiginosa.
I brevetti della Cina e le risposte necessarie
Nel 2023, la Cina ha depositato più brevetti internazionali di qualsiasi altro Paese al mondo, e oggi forma ogni anno più ingegneri di Stati Uniti, Europa e Giappone messi insieme. Il caso del nuovo modello DeepSeek, sviluppato interamente in Cina come diretto concorrente dei grandi modelli di intelligenza artificiale occidentali, dimostra che Pechino non si limita più a tenere il passo: ha iniziato a guidare. Ignorare questa trasformazione e trattare la Cina come fosse ancora un’economia da “copia e incolla” è una diagnosi profondamente sbagliata. Qualsiasi politica commerciale o industriale che non riconosca questa nuova realtà è destinata a fallire. La Cina oggi compete con strumenti propri — e il resto del mondo deve rispondere con intelligenza, non con nostalgia.
L’amministrazione Trump ha risposto a questa trasformazione in modo radicale e maldestro. Invece di elaborare una strategia intelligente per competere e imparare, ha optato per una guerra commerciale unilaterale. Sono stati imposti dazi molto elevati sui beni cinesi — alcuni fino al 25%, al 100% e oltre — nella speranza di recuperare competitività semplicemente penalizzando l’avversario. Ma i dazi non sono una strategia industriale. Anzi, l’assenza di una strategia chiara da parte degli Stati Uniti è apparsa in tutta la sua evidenza.
La guerra commerciale ha ampliato il divario
Lungi dal ridurre il divario con la Cina, questa guerra commerciale lo ha ampliato. Serviva un approccio diverso. Invece di applicare dazi indiscriminati che hanno danneggiato imprese e consumatori americani, gli Stati Uniti avrebbero dovuto guidare una coalizione internazionale. Un’alleanza compatta tra le democrazie industriali — Europa, Giappone, Corea del Sud, Australia, Canada — avrebbe potuto porre alla Cina un bivio strategico: avviare riforme profonde del proprio modello economico oppure affrontare un’escalation progressiva e coordinata di dazi imposti da tutto il blocco. Una pressione multilaterale avrebbe avuto maggiore legittimità, prevedibilità e forza, evitando l’isolamento diplomatico e commerciale causato dall’unilateralismo di Washington.
Questa coalizione avrebbe potuto esigere da Pechino impegni strutturali chiari: abbandonare gradualmente un’economia trainata dagli investimenti pubblici e dalle esportazioni per orientarsi verso un modello più equilibrato e sostenibile, fondato sul consumo interno. Ciò implicherebbe anche un’apertura reale ed efficace del mercato cinese alle imprese straniere, con reciprocità autentica in termini di accesso e trattamento commerciale.

Perché le aziende occidentali devono ancora operare in Cina solo tramite joint venture al 50%, mentre le imprese cinesi godono di piena libertà negli Stati Uniti e in Europa? Un sistema più equo richiederebbe alla Cina di seguire le stesse regole che l’hanno favorita per decenni: consentire e incentivare le imprese cinesi a creare joint venture in Occidente, condividere tecnologie, processi industriali e catene del valore. Così, i Paesi ospitanti potrebbero replicare parte della strategia vincente cinese — imparando dai propri partner e rafforzando le capacità industriali interne.
La strategia di Trump guarda al passato
Una strategia del genere aprirebbe molte opportunità. La Cina potrebbe continuare a beneficiare dei propri investimenti all’estero, ampliando la capacità produttiva globale. Allo stesso tempo, Stati Uniti ed Europa potrebbero fare con la Cina ciò che la Cina ha fatto con loro: apprendere, assorbire conoscenze, accelerare la propria trasformazione industriale. Invece di chiudere la porta al Paese che guida la nuova rivoluzione tecnologica, l’Occidente avrebbe dovuto entrarvi con decisione — non per arrendersi, ma per recuperare terreno.
Invece, la strategia di Trump ha guardato al passato: proteggere i motori a combustione invece di promuovere quelli elettrici, rilanciare il carbone invece di puntare sull’idrogeno, aggrapparsi al fracking quando il futuro indica chiaramente l’elettrificazione e la sostenibilità. Mentre la Cina pianifica con vent’anni di anticipo, investendo in ricerca e formazione su larga scala, gli Stati Uniti si rifugiano in uno slogan vuoto: drill, baby, drill — trivella, tesoro, trivella. Anziché prepararsi a competere nel XXI secolo, Trump agisce come se fosse ancora negli anni ’70.
I tre pilastri per sfidare la Cina
Una strategia industriale efficace per affrontare la sfida cinese avrebbe dovuto poggiare su tre pilastri. Primo, identificare i settori chiave — semiconduttori, energia pulita, tecnologie di accumulo — e mobilitare risorse pubbliche e private su di essi. Secondo, rafforzare le alleanze globali per coordinare politiche, condividere rischi e capacità. Terzo, avviare un serio tavolo negoziale con la Cina — non per scontro gratuito, ma per fermezza strategica.
La vera minaccia non è mai stata che la Cina copiasse. La vera minaccia — ancora oggi — è che innova più in fretta. E invece di punirlo, dovremmo imparare da questo. È tempo che le democrazie industriali adottino una mentalità da XXI secolo: né protezionismo cieco, né globalismo ingenuo, ma cooperazione strategica con condizioni chiare, trasparenza e beneficio reciproco. Il punto non è arrendersi alla Cina, ma sapere come competere con essa. Non si tratta di chiudersi, ma di prepararsi. Non si deve tornare indietro, ma arrivare al futuro con gli strumenti giusti.
E per farlo, servono più dei dazi. Serve visione.
