categoria: Vendere e comprare
IRI 2.0, una gran voglia di Belle Époque per non pensare al futuro
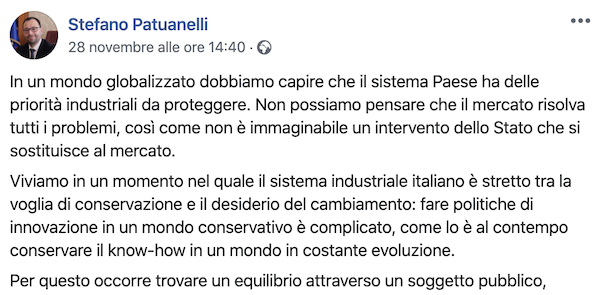
Sembra paradossale sentir parlare di IRI non in chiave storica, ma in prospettiva di attualità. Descrive però abbastanza bene lo smarrimento di un’intera classe dirigente pubblica e privata. Il dibattito è stato avviato dal ministro Patuanelli, titolare del MISE, che ha rievocato la necessità di un maggiore intervento pubblico nell’economia.
Ecco parte del suo pensiero, espresso in un post su Facebook.
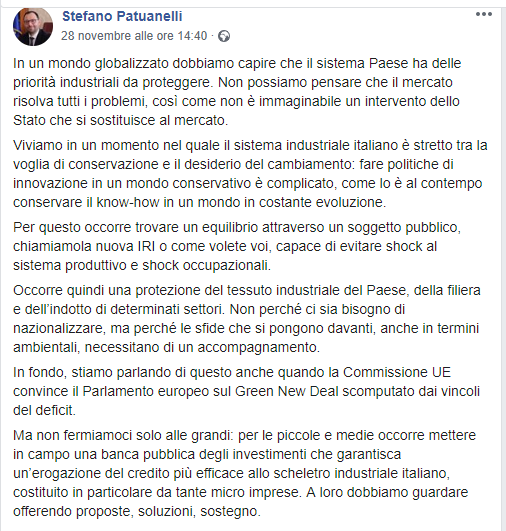
Non sono riuscito a comprendere quali dovrebbero essere le funzioni del soggetto pubblico evocato. In un primo momento il post menziona politiche di innovazione, facendo pensare ad investimenti pubblici in ricerca e sviluppo. Poi però si passa al desiderio di evitare shock al sistema produttivo e occupazionale, al green new deal ed infine ad una banca pubblica.
Mi è venuta in mente l’immagine macabra dell’Idra di Lerna, ma non vorrei essere così pessimista, né sembrare troppo duro nel giudicare il legittimo pensiero del Ministro. Vorrei solo riflettere su due punti. Il primo legato ai casi dello Stato “risanatore” di imprese private in difficoltà, il secondo inerente ai casi dello Stato “proprietario” di imprese (già private o create ex novo).
Partiamo dal primo punto. Il nostro Paese ha la tendenza di adottare -sull’onda di asserite emergenze- misure pubbliche straordinarie che nascono con l’intento di essere temporanee, ma finiscono inesorabilmente per divenire permanenti (la stessa IRI nacque nel lontano 1933 come istituto temporaneo, per poi diventare permanente pochi anni dopo).
La sensazione è che il movimento trasversale che appoggia la visione del ministro sull’argomento (evitare shock, proteggere tessuti industriali), tutt’altro che isolata, sia coerentemente in linea con la piega (o piaga) di curatore fallimentare che lo stesso MISE ha ormai assunto. Una piega che allontana il ministero dalle possibili iniziative riguardanti politiche orientate allo sviluppo economico.
Dai dati forniti dal Ministro, apprendiamo che quasi il 70% dei tavoli di crisi è aperto da più di tre anni, con ben 28 casi aperti da più di sette anni. Se allarghiamo l’inquadratura oltre il MISE, si tratta di una caratteristica tricolore consacrata, che tende a rimandare sine die decisioni che possano apparire impopolari. Beninteso, nessuno gioisce in caso di chiusura di un’impresa o di licenziamenti di incolpevoli, ma bisogna chiedersi che senso abbia mantenere in vita aziende oramai fuori dal mercato o facenti parte di settori superati dalla tecnologia. Ciò non significa che un’impresa in crisi non possa essere risanata, tutt’altro, ma ci sono dei casi in cui è evidente che non vi siano speranze. Eppure, si prosegue imperterriti con l’accanimento terapeutico, con l’intento dichiarato di salvaguardare l’occupazione.
Un fenomeno distorsivo ed atavico ben spiegato da Michele Grillo[1]: «(…) il modello è costruito sul presupposto logico che il lavoratore recuperi il proprio (cioè) lo stesso posto di lavoro (…) si è legata l’assicurazione dei lavoratori alla sopravvivenza dell’impresa. A trarre beneficio sono state però le imprese meno “adatte”, che sono proprio quelle che il meccanismo concorrenziale spinge ad uscire dal mercato. (…) Essa ha inoltre offerto la base per un legame collusivo tra sindacato dei lavoratori e sindacato delle imprese che ha trovato espressione stabile nell’arena politica e che è stato favorito dalla circostanza che al finanziamento della cassa integrazione contribuiscono non solo imprese e lavoratori ma anche risorse statali.»
Un modello che alloca risorse pubbliche in modo del tutto inefficiente, allontanando ancor di più il Paese dal sentiero perduto della crescita.
Passiamo al secondo punto di riflessione, relativo al capitolo della proprietà delle imprese. Da Alitalia a Ilva, passando per Autostrade, sono in molti ad invocare nazionalizzazioni. Ed anche questo è un pensiero abbastanza trasversale tra le forze politiche. Ma da dove nasce il problema delle imprese private secondo i fautori delle nazionalizzazioni?
Secondo il ministro Patuanelli ad esempio «Il MoVimento 5 Stelle non ha nel dna l’ostilità verso le grandi #imprese e le multinazionali, quanto piuttosto un rifiuto verso il profitto fine a se stesso o, peggio, un #profitto mai reinvestito e maturato sul sudore, sulle spalle e sui talenti delle persone».
Patuanelli, per quanto mi risulta, non si esprime nettamente a favore delle nazionalizzazioni, ma individua il problema -a suo dire- dell’impresa privata: il profitto fine a sé stesso (e questo fa molto 1848, ma ho già scritto sulla demonizzazione del profitto su questi pixel). Il pensiero ideologico sottostante a simili dichiarazioni è più o meno il seguente: «dato che l’impresa pubblica non ha il fine del profitto, può lavorare per interessi generali più meritevoli». Un pensiero errato sotto un duplice profilo.
In primo luogo, non è vero che l’impresa di proprietà pubblica non possa essere guidata dal fine del profitto. Anche lo Stato azionista può avvantaggiarsi dei profitti generati dalle imprese nelle quali partecipa. Questo avviene, anche in Italia, grazie ad alcune situazioni di monopolio o ad alcune imprese partecipate ben performanti. E come azionista, lo Stato usa i soldi ricavati per destinarli ad altri scopi. Anche quelli sono soldi generati dal “sudore” delle persone, che finiscono per beneficiare altre persone.
In secondo luogo, è errato altresì pensare che sarebbe meglio se le imprese pubbliche o partecipate non perseguissero la strada del profitto. Quando ciò avviene, è solitamente l’inizio della fine per quell’impresa. Lo Stato azionista, difatti, può anche utilizzare le imprese partecipate per un altro tipo di profitto, espresso in termini di consenso politico. In questo caso il processo è inverso rispetto al primo esempio, perché vengono solitamente ripagate le perdite di aziende con i soldi dei contribuenti. È quello che avviene con il caso Alitalia ed è ciò che ha portato al fallimento del modello IRI. Paolo Bricco, su Il sole 24 Ore del 30 novembre, ne ha stimato il costo per i contribuenti in 120 mila miliardi di vecchie lire.
In generale, si fa fatica a comprendere che non è dirimente il tipo di proprietà, pubblica o privata. Ciò che conta veramente è se l’impresa svolga la sua attività con criteri di governance societaria moderni e in un regime di mercato concorrenziale oppure se sia favorita (o danneggiata) dall’intervento pubblico. È lo stesso principio che guida la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Ecco perché in alcune fasi storiche anche il fenomeno del capitalismo pubblico ha funzionato in Italia, grazie all’iniziale benign neglect della Democrazia Cristiana ed all’autonomia di cui hanno goduto alcuni manager pubblici illuminati. Ma quando le necessità di consenso hanno finito per causare un’ingerenza della politica della gestione delle imprese, si è dato vita al tristemente noto “carrozzone” di sprechi e di “cattedrali nel deserto”.
Come scritto da Barca e Trento[2], «In conclusione, è nostra opinione che l’attribuzione alle imprese a partecipazione statale di obiettivi diversi dal profitto, rendendo impossibile l’esercizio di una supervisione autonoma su quelle imprese, renda inevitabile la commistione fra impresa pubblica e partiti; e finisca per essere il cavallo di Troia dell’uso “partitico” dell’impresa pubblica.»
Invece di interrogarsi sui problemi strutturali del capitalismo italiano e su come rimuovere gli ostacoli che frenano la competitività e la produttività delle nostre imprese, sembra che si vogliano mettere qua e là toppe peggiori dei buchi, con il tutto condito da una narrazione da Belle Époque colma di miti e leggende.
Twitter @frabruno88
[1] Grillo M., “Tutela della concorrenza e diffusione sociale del rischio”, in “Concorrenza, mercato e crescita in Italia: il lungo periodo”, a cura di Gigliobianco A. e Toniolo G., Marsilio editori 2017, cit. pp. 548-549.
[2] Barca F., Trento S., “La parabola delle partecipazioni statali”, in “Storia del capitalismo italiano”, a cura di Barca F., Donzelli editore 1997, cit. pp. 216-217.
