categoria: Draghi e gnomi
Le unioni monetarie servono a evitare le guerre

In macroeconomia, il rapporto tra l’inflazione e la disoccupazione, a partire dalla fine degli anni ’50, è stato interpretato secondo la Curva di Phillips, una rappresentazione grafico-cartesiana in base alla quale alla riduzione del potere d’acquisto della moneta corrisponderebbe un aumento dei posti di lavoro e viceversa. La relazione è chiaramente segnata dalla proporzionalità inversa. Tale meccanismo ci conduce immediatamente al valore della domanda interna, la cui crescita, naturalmente, diventa la funzione primaria del trade off in questione. Di conseguenza, chi ha compiti di politica monetaria, nel regolare i prezzi e nel tentare di raggiungere obiettivi di stabilità che tutelino i cittadini e Stati, diventa protagonista di un terribile AUT-AUT, che, in soldoni, può essere reso così: o consentiamo alla gente di acquistare il pane a un prezzo ragionevole, ma rinunciamo a un po’ di occupazione, o miglioriamo l’occupazione, ma rinunciamo a un po’ di pane. Tra le altre cose, come si nota facilmente dal grafico di Borsa Italiana, nessuna autorità monetaria può mantenere molto a lungo l’inflazione a livelli elevati perché si rischierebbe di stressare la popolazione, causando a essa difficoltà di sopravvivenza.
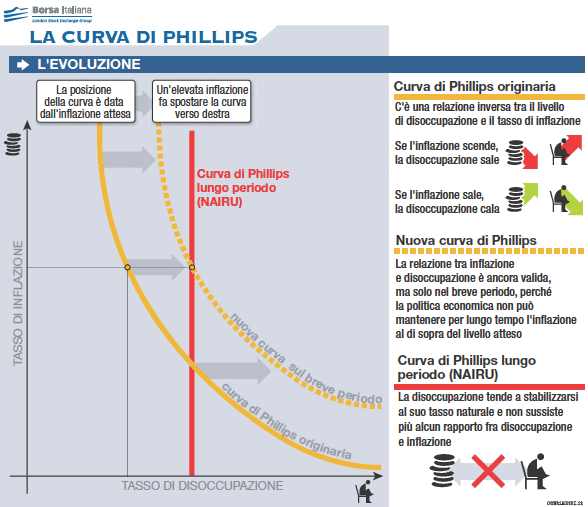
Sul modello populista
Tutte le volte in cui un governo amplia troppo la spesa pubblica e riduce in modo inadeguato la tassazione, si corre il rischio di generare una crisi della bilancia dei pagamenti perché la domanda interna di beni e servizi aumenta e così pure l’importazione. In linea teorica, questo fenomeno dovrebbe almeno migliorare il tasso d’occupazione, far crescere cioè la quota d’occupazione stabile. Quindi, di fatto, a voler essere scolastici, i propositi del governo gialloverde potrebbero rientrare in una ‘logica’ di sistema. L’uso del condizionale tuttavia è doveroso perché, a questo punto, non è spiegabile né, tanto meno, ‘logico’ (…per l’appunto!) la misura del reddito di cittadinanza, che viene a configurarsi come una sovrapposizione irrazionale, un che di ridondante, specie se del tutto separato dal rapporto diretto con l’economia reale.
Il ciclo recessivo da cui proveniamo, tra le altre cose, altera le leggi della domanda e dell’offerta, inducendo il consumatore al risparmio o alla cautela, cosicché l’aumento della domanda potrebbe non essere così prevedibile e, ancora una volta, ‘logico’ come la ‘scuola elementare’ d’una certa economia vorrebbe.
Il risultato d’una manovra esasperatamente razionale potrebbe essere la genesi della totale irrazionalità. Paradossalmente: potrebbe materializzarsi una curva macroeconomica fantasma, vale a dire una variazione meccanico-causale di brevissima durata e, oltretutto, alquanto dannosa. Non è un caso che lo stesso Keynes, padre del welfare, abbia parlato di animal spirits, cioè di meccanismi del comportamento umano talmente incalcolabili che gli economisti fanno una certa fatica a prevederne il flusso. A suo modo di vedere, in questi casi, lo Stato dovrebbe avocare a sé il potere d’investimento, assumendosi anche il rischio d’impresa.
Nell’epoca keynesiana, si fece apprezzare un economista meno noto al grande pubblico e, di conseguenza, molto meno citato, William Henry Beveridge. Egli divenne famoso per due rapporti sullo stato sociale, sebbene quello che c’interessi di più adesso è quello intitolato Full Employment in a Free Society (1944) perché solleva in modo ‘traumatico’ – lo si ricava facilmente dal titolo – il problema della piena occupazione. Morale della favola: il cane si morde la coda. Concepire un aumento dell’indebitamento netto strutturale e non includere investimenti nelle infrastrutture, nell’innovazione e in piani d’impresa vuol dire inequivocabilmente contraddire i presupposti essenziali dell’economia sociale da cui ci si lascia tanto ispirare.
Dunque, non è stato vano chiamare in causa i nobili autori del welfare: non s’è trattato di mero citazionismo, ma del tentativo di capire quali possano essere le precondizioni d’una certa manovra economica. Nello stesso tempo, occorre ricordare a qualche smemorato che l’Italia non ha affatto un apparato finanziario simile a quello britannico né possiede un forza industriale simile a quella degli Stati Uniti. Ne consegue che siamo costretti a rilevare per lo meno una sproporzione preoccupante nella politica economica del governo.
Le variabili dimenticate
Sarebbe bene che pure coloro che non hanno dimestichezza con la macroeconomia fossero informati del fatto che ogni teoria è basata su un modello, ogni modello è basato su delle relazioni tra variabili e ogni relazione è espressa da una funzione. In altri termini, se si sente dire che il governo Renzi o Gentiloni aveva fissato il deficit, per esempio, a X+2, mentre il governo ‘Di Maio-Salvini’, avendolo fissato X+3, non ha fatto alcunché di sbagliato e differente, allora si deve fare un passo indietro e studiare come le variabili esogene abbiano condizionato quelle endogene. In pratica, non è possibile giudicare l’operato dell’uno solo perché l’altro ha fatto qualcosa di simile. Insomma, se in una famiglia con due figli, il padre ha regalato una macchina al primogenito, non è detto che egli, qualche anno dopo, faccia bene ad acquistarne una pure per il secondogenito al solo scopo di non generare disparità. Utilizzando un linguaggio improprio e vago, si modifica in modo irreversibile la realtà di chi ci ascolta o ci legge: è errato fare dei confronti tra i governi prendendo i numeri in valore assoluto, si creano solamente figure e controfigure della demagogia.
Socialdemocrazia, disoccupazione e guerre europee
Riportando l’analisi sullo scottante tema della socialdemocrazia, giova rivedere i dati sulla disoccupazione pubblicati da Eurostat per far notare che alcuni di quei paesi che in Europa e nel mondo sono noti per le massicce e inimitabili misure di welfare, quali sono la Svezia e la Danimarca, hanno dovuto fare seriamente i conti – anch’essi – con l’aumento della disoccupazione. Nel decennio 2003-2012, la Svezia è passata dal 6,6% all’8% di disoccupazione e la Danimarca dal 5,4% al 7,5%. Dunque: si può comprendere che l’equazione tra stato sociale e miglioramento dell’occupazione non è così scontata come qualcuno vuole farci credere.
A questo si deve pure aggiungere che l’Europa del Nord gode di un assetto storico-politico e infrastrutturale che noi non possediamo e neppure sogniamo, a dire il vero. I dati sull’occupazione, in particolare, hanno trasformato, per qualche anno, l’Europa meridionale in una sorta di ‘impotenza’ socio-economica, se si considera che la Spagna e la Grecia, già qualche anno dopo il crack di Lehman Brothers, potevano denunciare, rispettivamente, il 25% e il 24,3% di disoccupazione, quote spaventose di popoli alla deriva e con un’elevata esposizione al rischio di povertà.
Ancora una volta, alla luce di queste elementari acquisizioni, ci si potrebbe interrogare con estrema faciloneria: a che serve un’Unione Europea, se non riesce a proteggere gli Stati membri durante una dura fase recessiva? Di fatto, l’Europa confederale non ha una storia; il che potrebbe trarre in inganno l’opinione pubblica: tutti i tentativi noti di farne un ‘territorio’ unico, d’altronde, sono stati invasivi, tirannici, aggressivi e opera di imperatori o aspiranti imperatori ed eserciti. Il concetto di Unione, però, non deve essere scambiato con quello di Confederazione né si deve mai tentare la via del paragone con gli Stati Uniti. Dal nostro punto di vista, la risposta alla domanda “a che servono l’Unione Europea e, a fortiori, la moneta unica?” è molto più a portata di mano di quanto s’immagini: le unioni monetarie servono principalmente a evitare le guerre e le devastazioni.
Ad alcuni sovranisti frettolosi e insensibili certe affermazioni possono giungere come impertinenti ed esagerate, ma non dobbiamo dimenticare che, di là dalla seconda grande guerra, da cui ci separano solamente settant’anni, la dichiarazione di neutralità dell’Austria risale al 1955, la rivoluzione ungherese è del 1956, la primavera di Praga del 1968, la rivolta greca contro la dittatura dei colonnelli del 1973, il regime di Salazar in Portogallo si concluse solo nel 1974 con la rivolta dei garofani, il massacro di Tbilisi ci riporta indietro solo di ventinove anni, al 1989, anno che il mondo ricorda per la caduta del muro di Berlino e anno in cui ha inizio la rivoluzione rumena di Timișoara contro il regime di Ceaușescu, il massacro di Srebrenica avvenne nel 1995 e, nel vicinissimo decennio 1991-2001, si sono svolte le guerre jugoslave.
“Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è si cara,
come sa chi per lei vita rifiuta”
Purgatorio, Canto I, vv 70-72
Il controllo dell’inflazione e l’emergenza sovranazionale
Una delle cause per le quali, nella storia, i popoli si sono sentiti motivati a combattere contro altri popoli è indubbiamente il disagio economico, il cui risvolto tecnico e materiale prende il nome di inflazione. Quando il potere d’acquisto di un salario si riduce ai minimi termini e la gente deve fare la fila per ore allo scopo di acquistare una certa razione di latte o di pane, le rivolte assumono il valore di un rimedio accettabile. Ebbene, l’Unione Europea, almeno in questo, ha svolto in modo brillante la propria funzione. Il guaio è che tutti noi, in un periodo di benessere, quantunque relativo, non pensiamo affatto che in un tempo non lontano i nostri nonni mangiavano a stento né, tanto meno, siamo disposti a pensare che, fino a qualche anno fa, i nostri vicini di casa avevano ancora gli stessi problemi che noi, invece, avevamo settant’anni fa.
Prendendo in esame sempre il decennio 2003-2012, ma spostando il focus sui dati dell’inflazione prodotti da Eurostat, troviamo ampia conferma dell’ipotesi appena fatta circa il ruolo dell’UE. Quella stessa Spagna che nel decennio in studio è passata da un tasso di disoccupazione dell’11,4% a uno del 25%, in fatto d’inflazione, invece, ha goduto d’una certa stabilità: dal 3,1% del 2003 al 2,4% del 2012. Allo stesso modo la Grecia: dal 3,4% del 2003 all’1%. La Romania, che partiva dal 15% d’inflazione, è addirittura arrivata al 3,4%, pur non adottando l’euro ed essendo un ex paese del blocco sovietico. Sullo stesso piano, possiamo collocare la Repubblica Ceca, che, nel 2003, aveva un tasso d’inflazione pari al 20,1%, mentre, nel 2012, aveva raggiunto il 3,5%. Crediamo che, a questo punto, gli esempi, siano sufficienti a che il lettore si renda conto che entrare a far parte di un sistema sovranazionale di garanzia era un’emergenza. Quale che sia il giudizio degli ultimi tempi sui lavori della BCE e della Commissione Europea, neppure ai più agguerriti tra i sovranisti dovrebbe sfuggire questa obiettività storico-economica.
Quando certi buontemponi contestano la crescita del PIL dei paesi dell’ex cortina di ferro dicendo che è troppo facile crescere partendo dal nulla, bisognerebbe far notare loro che il primo obiettivo di un garante sovranazionale è quello di offrire a tutti gli stati membri delle condizioni di omogeneità monetaria. Di conseguenza, i numeri della crescita di alcuni paesi non sono affatto uno scompenso di politica economica, ma rappresentano anzitutto un successo sociale.
Twitter @FscoMer
